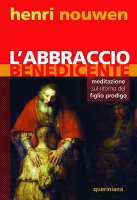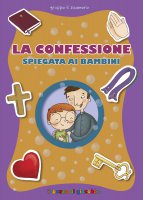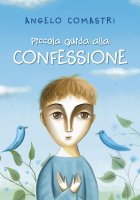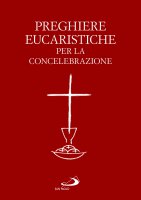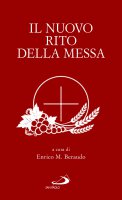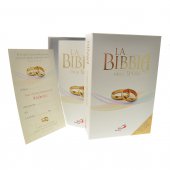Sacramentale
Consigliati in questo reparto
I più venduti
Tutti i libri del reparto «Sacramentale»

Libro
EAN 9791254824016 |
di Antonio Miralles | -
Edusc
(maggio 2025)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
20,00 € →
19,00 €
Questo volume indaga, con sapiente equilibrio tra erudizione e profondità spirituale, il mistero dei sacramenti di guarigione: la Penitenza e…
|
|

Libro
EAN 9788892246966 |
di Cristina Simonelli | -
San Paolo Edizioni
(aprile 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
15,00 € →
14,25 €
Parlare di Chiesa e sacramenti ci pone in continuità con le donne e gli uomini del IV secolo, con i quali abbiamo tanto in comune, pur nelle…
|
|

Libro
EAN 9788897921738 |
di Scott Hahn | -
Il Timone
(aprile 2025)
Normalmente disponibile in 2/3 giorni lavorativi
18,00 € →
17,10 €
I sette sacramenti della Chiesa Cattolica, hanno un potere, ma lo conosciamo davvero? Scott Hann mostra come le alleanze di Dio, con Adamo,…
|
|

Libro
EAN 9791254823880 |
di Manlio Sodi | -
Edusc
(aprile 2025)
Disponibilità immediata
20,00 € →
19,00 €
Molteplici sono i "sentieri" che la Parola di Dio percorre nei ritmi del tempo e nella storia della persona. Quello offerto dalla liturgia…
|
|

Libro
EAN 9791256270507 |
di Maria Vincenzo Romano (Padre) | -
Marcianum Press
(marzo 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
36,00 € →
34,20 €
Spedizione gratuita
Ancora una catechesi sui sacramenti? Si è scritto tanto su questo tema, ma spesso un'eccessiva attenzione alla liturgia che li esprime,…
|
|
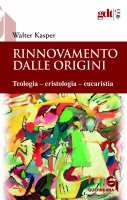
Libro
EAN 9788839934659 |
di Walter Kasper | -
Queriniana Edizioni
(febbraio 2025)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
27,00 € →
25,65 €
Secondo il cardinale Walter Kasper, una risposta alla crisi della tradizione nel cristianesimo occidentale richiede molto di più di una…
|
|

Libro
EAN 9788892228658 |
di Ratzinger) Benedetto XVI (Joseph | -
San Paolo Edizioni
(dicembre 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
14,00 € →
13,30 €
«Sacramento significa in primo luogo che non siamo noi uomini a fare qualcosa, ma Dio in anticipo ci viene incontro, ci guarda e ci conduce…
|
|

Libro
EAN 9788892245129 |
di Angelo Lameri | -
San Paolo Edizioni
(agosto 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
16,00 € →
15,20 €
Questo volume vuole porsi in ascolto di ciò che l'insegnamento della Chiesa afferma a proposito della validità della celebrazione dei…
|
|

Libro
EAN 9788826609164 |
di Dicastero per la Dottrina della Fede | -
Libreria Editrice Vaticana
(luglio 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
2,80 € →
2,66 €
Con la nota Gestis verbisque il Dicastero per la Dottrina della Fede intende offrire alcuni elementi di carattere dottrinale «in ordine al…
|
|
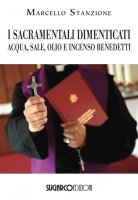
Libro
EAN 9788871988283 |
di Marcello Stanzione | -
SugarCo
(aprile 2024)
Normalmente disponibile in 2/3 giorni lavorativi
16,80 € →
15,96 €
Il libro tratta in modo speciale delle benedizioni ad alcuni elementi naturali cui normalmente ricorrono i sacerdoti o gli esorcisti, che li…
|
|
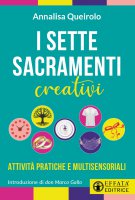
Libro
EAN 9788869290558 |
di Annalisa Queirolo | -
Effatà
(febbraio 2024)
Normalmente disponibile in 15/16 giorni lavorativi
12,00 € →
11,40 €
Un percorso multisensoriale che permetterà a bambini/e e ragazzi/e di conoscere i sette sacramenti attraverso giochi, colori, odori, pranzi,…
|
|

Libro
EAN 9791281584013 |
di Gianandrea Di Donna | -
Valore Italiano Editore
(dicembre 2023)
Normalmente disponibile in 10/11 giorni lavorativi
25,00 €
Quando un bambino di otto giorni deve ricevere il proprio nome, la Chiesa di Costantinopoli prega Dio: abbi cura di questo figlio…
|
|
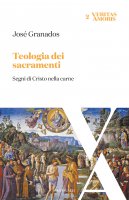
Libro
EAN 9791259623676 |
di José Granados | -
Cantagalli Edizioni
(novembre 2023)
Normalmente disponibile in 15/16 giorni lavorativi
27,00 € →
25,65 €
Questo saggio presenta i sacramenti dal punto di vista del linguaggio del corpo, un linguaggio che ci apre all'amore fedele e fecondo. In…
|
|
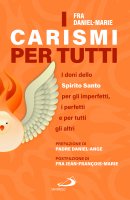
Libro
EAN 9788892242005 |
di Fra Daniel-Marie | -
San Paolo Edizioni
(giugno 2023)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
18,00 € →
17,10 €
Guarigioni. Profezie. Interpretazioni delle profezie. Capacità di parlare e capire lingue antiche dimenticate o sconosciute. Sembrano…
|
|
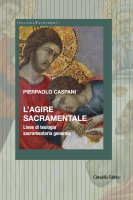
Libro
EAN 9788830818842 |
di Pierpaolo Caspani | -
Cittadella
(giugno 2023)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
18,50 € →
17,57 €
Il volume vuole offrire una presentazione il più possibile ordinata e organica degli elementi essenziali per la comprensione credente del…
|
|

Libro
EAN 9788851426668 |
di Salvatore Giuliano | -
Ancora
(febbraio 2023)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
15,00 € →
14,25 €
Questo testo si propone, nell'approfondimento sistematico della teologica sacramentaria, di far comprendere meglio e amare di più la…
|
|
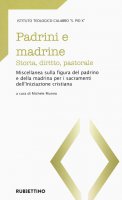
Libro
EAN 9788849875638 |
di M. Munno | -
Rubbettino Editore
(febbraio 2023)
Normalmente disponibile in 15/16 giorni lavorativi
15,00 € →
14,25 €
Il ruolo di padrino e madrina, fin dai primi secoli della storia della Chiesa, ha avuto una particolare rilevanza nell'Iniziazione cristiana.…
|
|
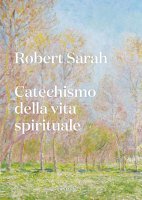
Libro
EAN 9791259622815 |
di Robert Sarah | -
Cantagalli Edizioni
(gennaio 2023)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
25,00 € →
23,75 €
«Non ho cercato di scrivere un riassunto della fede cristiana. Abbiamo già a disposizione il Catechismo della Chiesa Cattolica e il suo…
|
|
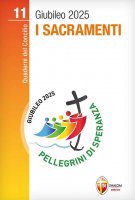
Libro
EAN 9788884048240 |
di Dominik Jurczak | -
Shalom
(dicembre 2022)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
4,00 € →
3,80 €
Dominik Jurczak ci conduce a una riflessione: parliamo molto dei sacramenti della Chiesa e sappiamo che sono importanti, anche perché…
|
|
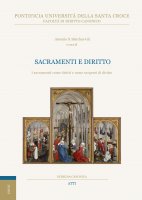
Libro
EAN 9791254820827 |
Edusc
(novembre 2022)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
30,00 € →
28,50 €
Il presente volume raccoglie gli Atti del XXVI Convegno di studi della Facoltà di Diritto Canonico, nel quale si è riflettuto su alcuni…
|
|
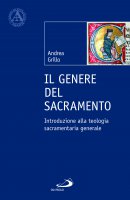
Libro
EAN 9788892229556 |
di Andrea Grillo | -
San Paolo Edizioni
(settembre 2022)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
35,00 € →
33,25 €
Spedizione gratuita
Nel corso degli ultimi due secoli la rilettura dell'esperienza ecclesiale e la sua mutata espressione mediante categorie differenti hanno…
|
|

Libro
EAN 9788830818491 |
di Sandro Vitalini, Assunta Steccanella, Fulvio Ferrario | -
Cittadella
(agosto 2022)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
3,50 € →
3,32 €
Una strada per vivere da esseri umani? Aprirsi all'amore del Dio di Gesù Cristo giorno per giorno, dalla nascita alla morte.
|
|
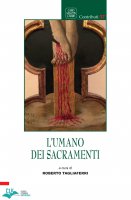
Libro
EAN 9788873673002 |
CLV Edizioni Centro Liturgico Vincenziano
(giugno 2022)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
33,00 € →
31,35 €
Spedizione gratuita
Il problema maggiore di cui la pratica dei sacramenti oggi soffre sembra riguardare il loro radicamento e la loro rilevanza sul piano…
|
|
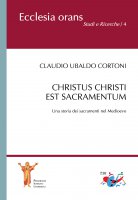
Libro
EAN 9791280562227 |
di Claudio U. Cortoni | -
Editrice Domenicana Italiana
(maggio 2022)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
19,00 € →
18,05 €
Il manuale ripercorre lo sviluppo della sacramentaria nel Medioevo in quattro parti:
- I: considerazioni sul nesso tra ecclesiologia e vita…
|
|

Libro
EAN 9788825047059 |
di Anna Morena Baldacci, Sebastiano Bertin, Luca Mazzinghi, Serena Noceti, Assunta Steccanella, Nadia Toschi | -
Edizioni Messaggero
(marzo 2022)
Disponibilità immediata
17,00 € →
16,15 €
La pubblicazione nel gennaio 2021 del motu proprio di papa Francesco Spiritus Domini circa l'accesso delle donne al ministero istituito del…
|
|
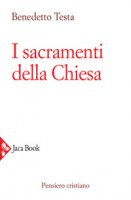
Libro
EAN 9788816417434 |
di Testa Benedetto | -
Jaca Book
(ottobre 2021)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
30,00 € →
28,50 €
Questo manuale introduce alla comprensione dei sacramenti come avvenimenti di grazia che continuano oggettivamente nella storia i gesti…
|
|

Libro
EAN 9788830817708 |
di Florio Mario | -
Cittadella
(agosto 2021)
Disponibile in 5/6 giorni lavorativi
21,90 € →
20,80 €
In questo volume si propone al lettore una serie di saggi su temi e questioni di Teologia sacramentaria (la fondamentale e il settenario…
|
|
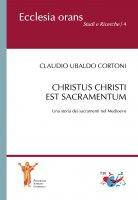
Libro
EAN 9788894876888 |
di Claudio U. Cortoni | -
Editrice Domenicana Italiana
(aprile 2021)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
27,00 € →
25,65 €
Il manuale ripercorre lo sviluppo della sacramentaria nel Medioevo in quattro parti:
- I: considerazioni sul nesso tra ecclesiologia e vita…
|
|
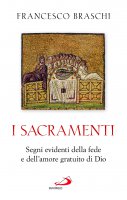
Libro
EAN 9788892224919 |
di Francesco Braschi | -
San Paolo Edizioni
(aprile 2021)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
12,00 € →
11,40 €
Per la stragrande maggioranza di noi il rapporto con i Sacramenti è iniziato ancora prima che ce ne rendessimo conto, quando i nostri genitori…
|
|
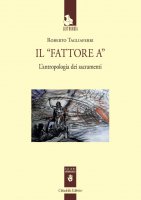
Libro
EAN 9788830817722 |
di Roberto Tagliaferri | -
Cittadella
(gennaio 2021)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
21,50 € →
20,42 €
Il "fattore A", ovvero la variabile antropologica nei sacramenti, è diventato un elemento centrale nella teologia, dopo che il Vaticano…
|
|

Libro
EAN 9791256271634 |
"Facciamo la coppia a nostra immagine". Nuova Alleanza - Un dialogo tra Sacra Scrittura e famiglia contemporanea
- Novità editoriale
di Christian-M. Steiner | -
Marcianum Press
(gennaio 2026)
Novità in arrivo
23,00 € →
21,85 €
Due eventi epocali caratterizzano il nostro tempo: l'Incarnazione di Dio in una famiglia, che dura da più di 2025 anni, e la fondazione della…
|
|

Libro
EAN 9791256393053 |
Il sacramento della Confessione
- Novità editoriale
di Raffaello Martinelli | -
Shalom
(novembre 2025)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
12,00 € →
11,40 €
|
|

Libro
EAN 9791280736642 |
L'Eucaristia - Farmaco d'immortalità
- Novità editoriale
di Remo Lupi | -
Dottrinari
(novembre 2025)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
4,80 € →
4,56 €
Oggi siamo alla costante ricerca del farmaco che risolva i nostri malanni. Anche la nostra società è in attesa di un farmaco che la guarisca…
|
|

Libro
EAN 9791259755384 |
Io sono come guardo - Lo sguardo di Cristo sull'amore di coppia
- Novità editoriale
di Luigi Maria Epicoco | -
Tau Editrice
(novembre 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
12,00 € →
11,40 €
Da ciò che riusciamo a vedere dipende gran parte della nostra vita e delle nostre scelte. Quando si ama, l'altro diventa il motivo per cui…
|
|

Libro
EAN 9788825059809 |
Il matrimonio - Un'avventura per cuori impavidi
- Novità editoriale
di Simone Olianti | -
Edizioni Messaggero
(novembre 2025)
Disponibilità immediata
18,00 € →
17,10 €
L'autore testimonia con competenza la sua fiducia nella scelta matrimoniale e nella possibilità di essere felici insieme, riscegliendosi di…
|
|

Libro
EAN 9791259755827 |
Cum gaudio
- Novità editoriale
Tau Editrice
(novembre 2025)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
15,00 € →
14,25 €
È il secondo libro della collana Oasi dell'Unione Apostolica Clero (UAC). Essa raccoglie articoli significativi, redatti da propri associati,…
|
|

Libro
EAN 9788839936240 |
Le nozze dell'agnello - Saggio filosofico sul corpo e l'eucaristia
- Novità editoriale
di Emmanuel Falque | -
Queriniana Edizioni
(novembre 2025)
Disponibile in 5/6 giorni lavorativi
53,00 € →
50,35 €
Spedizione gratuita
L'opera riflette sull'eucaristia come elemento centrale dell'umano e della cultura occidentale. Falque prende avvio alla domanda: «Come…
|
|

Libro
EAN 9791256392117 |
di Raffaello Martinelli | -
Shalom
(ottobre 2025)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
12,00 € →
11,40 €
Attraverso l’originale approccio che collega il testo alle immagini tramite delle slides in power-point, monsignor Martinelli, in questo…
|
|

Libro
EAN 9791280562814 |
Editrice Domenicana Italiana
(ottobre 2025)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
24,00 € →
22,80 €
Il presente volume raccoglie gli Atti della seconda Giornata di studio organizzata dalla rivista Ecclesia Orans sul tema "L'atto…
|
|

Libro
EAN 9791281465329 |
di Luca Fallica | -
Centro Eucaristico
(settembre 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
13,00 € →
12,35 €
In un saggio del 1960, Joseph Ratzinger affermava: «Il senso primario della Comunione non è l'incontro del singolo con il suo Dio - per questo…
|
|

Libro
EAN 9791256450855 |
di Carlos Encina Commentz | -
OasiApp La Pietra d'Angolo
(agosto 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
8,00 € →
7,60 €
Utilizzando un elenco in ordine alfabetico di parole che hanno a che fare con il sacramento della Riconciliazione, l'autore descrive…
|
|

Libro
EAN 9791256450848 |
di Carlos Encina Commentz | -
OasiApp La Pietra d'Angolo
(agosto 2025)
Disponibilità immediata
6,00 € →
5,70 €
Questo libro contiene un elenco di consigli ed esortazioni pensati per perseverare con successo nel matrimonio, con la speranza che possa…
|
|

Libro
EAN 9791256392674 |
di Leandro Cioverchia | -
Shalom
(luglio 2025)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
9,00 € →
8,55 €
Alla luce del Vangelo e della spiritualità, il libro propone di scoprire o ritrovare, di celebrare e assaporare la grazia della…
|
|

Libro
EAN 9788830819795 |
di Gabriele Chiruzzi | -
Cittadella
(luglio 2025)
Disponibilità immediata
24,50 € →
23,27 €
«È il lavoro teologico, salutare e necessario, nel quale si inscrive la ricerca di Gabriele Chiruzzi, cui va un infinito ringraziamento. Oggi…
|
|

Libro
EAN 9791256392704 |
di Raffaello Martinelli | -
Shalom
(luglio 2025)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
10,00 € →
9,50 €
Attraverso l’originale approccio che collega il testo alle immagini tramite delle slides in power-point, monsignor Martinelli, in questo…
|
|

Libro
EAN 9791281618312 |
di Carmela Romano, Lorenzo Pasquariello | -
Rinnovamento nello Spirito (RnS)
(luglio 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
15,00 € →
14,25 €
Il Seminario di Vita nuova per l'effusione o battesimo nello Spirito costituisce il cuore dell'esperienza del Rinnovamento nello Spirito Santo…
|
|

Libro
EAN 9791281618329 |
di Carmela Romano, Lorenzo Pasquariello | -
Rinnovamento nello Spirito (RnS)
(luglio 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
12,00 € →
11,40 €
Il Seminario di Vita nuova per l'effusione o battesimo nello Spirito costituisce il cuore dell'esperienza del Rinnovamento nello Spirito Santo…
|
|

Libro
EAN 9788851430344 |
di Gianpaolo Salvini | -
Ancora
(luglio 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
13,50 € →
12,82 €
«Il nostro mondo è molto prosaico e in apparenza povero di sentimenti. Eppure ogni volta che assistiamo al coraggio di chi dichiara agli altri…
|
|

Libro
EAN 9788851430177 |
di Michele Aramini | -
Ancora
(luglio 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
13,00 € →
12,35 €
Questo libro vuole aiutare i fedeli a comprendere meglio il valore del perdono di Dio e il sacramento che egli ha affidato alla Chiesa.…
|
|

Libro
EAN 9791254824146 |
di Marcelo Fiães | -
Edusc
(giugno 2025)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
25,00 € →
23,75 €
«Se si volesse fare una diagnosi della situazione attuale circa il sacramento del matrimonio inserito nel tessuto ecclesiale, emergerebbero…
|
|

Libro
EAN 9791259754899 |
di Olinka Sironi | -
Tau Editrice
(giugno 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
25,00 € →
23,75 €
La natura e le caratteristiche dell'amore coniugale, così come emergono dal magistero di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, sono l'oggetto di…
|
|

Libro
EAN 9791256392483 |
di Pasqualino Di Dio | -
Shalom
(maggio 2025)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
7,00 € →
6,65 €
Ti sei mai chiesto cosa si cela dietro i gesti, le parole e i silenzi della santa Messa? Questo libro ti guida in un affascinante percorso…
|
|

Libro
EAN 9788892247031 |
di Valentina Angelucci | -
San Paolo Edizioni
(maggio 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
15,00 € →
14,25 €
Il percorso del fedele che partecipa alla Messa: è la strada che questo libro desidera farci intraprendere. Non si tratta semplicemente di un…
|
|

Libro
EAN 9791256750580 |
di Marco Mellino | -
Effatà
(maggio 2025)
Novità in arrivo
7,00 € →
6,65 €
Il lettore di queste pagine potrà constatare come il vescovo Marco aiuti pastoralmente a penetrare nel mistero dell'Eucaristia in maniera…
|
|

Libro
EAN 9791254824016 |
di Antonio Miralles | -
Edusc
(maggio 2025)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
20,00 € →
19,00 €
Questo volume indaga, con sapiente equilibrio tra erudizione e profondità spirituale, il mistero dei sacramenti di guarigione: la Penitenza e…
|
|

Libro
EAN 9791281917194 |
di Vincenzo Molinaro | -
Edizioni Sanpino
(maggio 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
13,00 € →
12,35 €
Un libro che si trasforma nel viaggio che un prete compie insieme a chi la Messa la porta dentro di sé o a chi non l'ha mai vissuta. L'autore…
|
|

Libro
EAN 9791256391325 |
Shalom
(aprile 2025)
Disponibile in 1/2 giorni lavorativi
2,90 € →
2,75 €
Un libretto elegante, completo e graficamente curato, pensato per accompagnare i futuri sposi nel giorno più bello della loro vita.…
|
|

Libro
EAN 9788831558266 |
di Francesco (Jorge Mario Bergoglio) | -
Paoline Edizioni
(aprile 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
8,90 € →
8,45 €
Il testo raccoglie tutte le quindici catechesi di papa Francesco dedicate alla Messa, in particolare alle diverse parti della liturgia…
|
|

Libro
EAN 9788892246966 |
di Cristina Simonelli | -
San Paolo Edizioni
(aprile 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
15,00 € →
14,25 €
Parlare di Chiesa e sacramenti ci pone in continuità con le donne e gli uomini del IV secolo, con i quali abbiamo tanto in comune, pur nelle…
|
|

Libro
EAN 9788897921738 |
di Scott Hahn | -
Il Timone
(aprile 2025)
Normalmente disponibile in 2/3 giorni lavorativi
18,00 € →
17,10 €
I sette sacramenti della Chiesa Cattolica, hanno un potere, ma lo conosciamo davvero? Scott Hann mostra come le alleanze di Dio, con Adamo,…
|
|
12 3 4 5 successivaavanti