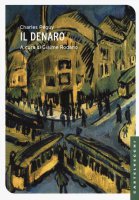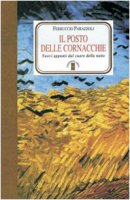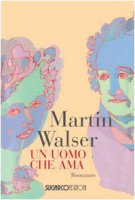Ci sarebbero tanti e buoni motivi per sconsigliare la lettura di questo libro. Innanzitutto perché è un romanzo eccessivamente lungo, debordante, con le sue mille pagine piene di parole che si inseguono quasi senza fine, con i rari a capo e i dialoghi inseriti direttamente nel testo, schiacciati dal ritmo tetragono della narrazione, e con la ripetizione ossessiva dei gradi militari (rigorosamente in tedesco) che caratterizza la maggior parte dei personaggi. E poi perché le interminabili digressioni, che interrompono l’intreccio (per esempio quella sulla lingua, gli usi e costumi di popolazioni caucasiche scomparse da secoli), potrebbero interessare a non più di cento persone sulla terra. E che dire del linguaggio osceno, macabro, ulceroso, violento, sanguinante, fecale, rivoltante, che imbratta il testo oltre il limite del sopportabile?
Il protagonista, infine, è quanto di più umanamente ripugnante si possa immaginare. Un omosessuale pervertito, incestuoso, matricida, pluriomicida, che dà coscienziosamente il proprio contributo di ufficiale delle SS nell’organizzazione dello sfruttamento e dello stermino degli ebrei nella Germania hitleriana durante il secondo conflitto mondiale. Un uomo che, oltretutto, ci provoca spudoratamente sin dalle prime righe del sua narrazione: ci chiama fratelli, dice che la sua storia riguarda tutti, e che alla fine ciascuno di noi avrebbe potuto trovarsi al suo posto, e agire proprio come lui, se non peggio. Peraltro non cerca alibi, il protagonista; né ci nasconde alcuno dei suoi difetti, dei suoi vizi, delle sue malsane passioni; non cerca di mitigare le proprie criminali responsabilità dicendo – come hanno fatto molti gerarchi nazisti al processo di Norimberga – di aver semplicemente ubbidito a degli ordini. Né scioglie la propria cinica disumanità nel luogo comune dell’intera colpevolezza del popolo tedesco. Il suo racconto è sostanzialmente una sfida alla nostra intelligenza, alla nostra coscienza umana, alla nostra sensibilità più profonda. È un Dante che non si è mai salvato – né mai si salverà – e che ci racconta minuziosamente le colpe e le pene peggiori dell’Inferno, dove ormai vive, senza un Virgilio che lo guidi, senza una Beatrice che lo venga a redimere. Questo viaggiatore negli incubi del terzo Reich si è portato a letto i suoi poeti, oppure li ha fatti arrestare e torturare; ha sparato in faccia alle sue donne, dopo averle baciate, ha infine gettato nel fango l’unica possibilità d’amore normale che il destino gli aveva offerto.
Perché la sua vera passione amorosa, la sostanza esistenziale dei suoi affetti non è nulla di normale: la ricerca di unione simbiotica con la sorella gemella, il suo corporeo identificarsi con lei nel dare se stesso agli altri uomini, la sua assoluta fedeltà a una ossessione perversa. D’altra parte non c’è nulla di normale in questo libro, se per normalità si intende qualcosa di equilibrato, di pacato, di umanamente comprensibile. Come è possibile capire e spiegare il genocidio degli ebrei polacchi, ucraini, ungheresi, francesi, olandesi? Come è possibile comprendere le ingiustizie, le violenze e gli orrori di una guerra così atrocemente combattuta da tutte le parti in causa? Come si fa a pensare l’impensabile, a sopportare l’odore nauseabondo di mille gesti folli, insensati, distruttivi, indegni di belve feroci? Eppure sono accaduti, eppure con essi dobbiamo fare i conti. Ecco perché è difficile, ma inevitabile – anzi, assolutamente necessario – fare i conti con questo libro. Bisogna leggerlo, con avidità e stupore, ribrezzo e passione; con la nausea che trabocca, anche; ma senza mai metterlo da parte, senza mai chiudere gli occhi e la mente, se davvero si vuole finalmente capire la Germania hitleriana, la Shoà, e la vita di milioni di uomini comuni che hanno improvvisamente portato l’inferno sulla terra. Leggere Le Benevole, un romanzo che nulla ha da invidiare – anzi, ha tutto da insegnare – ai più interessanti e approfonditi saggi di storia, significa innanzitutto avere la possibilità di capire meglio – e finalmente! – i fatti accaduti ai nostri non lontani antenati, e in tutti i loro aspetti, anche quelli sin qui inesplorati o rimossi.
Aspetti anche semplicemente – e clamorosamente – fraintesi; come si può facilmente dedurre dalla lettura di alcune recensioni a questo libro, quelle che istericamente lo vorrebbero porre tra i testi proibiti, perché pericolosamente portatore, a loro dire, di un’ideologia giustificazionista e revisionista. Come se per capire a fondo un crimine fosse necessario ascoltare sempre e solo la voce della vittima, mettersi sempre ed esclusivamente solo nei suoi panni; rimuovendo nel contempo l’esistenza del carnefice, a cui viene tolta senza appello la possibilità di dirci qualcosa, di raccontarsi. Abbiamo (giustamente) gli scaffali delle nostre biblioteche pieni delle testimonianze degli ebrei scampati allo sterminio, ma neppure un testo (o quasi) a raccontarci l’altra parte della realtà, quella degli assassini, senza la quale – ed è questo il primo messaggio scandaloso contenuto nel libro di Littell – nessuna comprensione è veramente possibile. Qui il malvagio ammette tutte le sue colpe, senza – lo abbiamo già detto – alcuna reticenza; addirittura prova pietà per le vittime (tranne che per quelle della sua personale follia omicida); sogna un mondo più giusto e più buono, dove l’arte, la cultura e i colori affascinanti dei paesaggi naturali possano rallegrare il nostro deleterio passaggio dal nulla al nulla.
Il fatto è – e in questo consiste il secondo scandaloso messaggio delle Benevole – che l’assassino ci accoglie tra le sue braccia, ci affascina con la sua indubbia personalità, ci intriga con i suoi deliri e le sue ossessioni, ci incuriosisce con la sua cultura, ci abbaglia con la sua testimonianza diretta, puntigliosa, quasi stenografica dei fatti e dei personaggi del terzo Reich; ma poi ecco che si toglie la sua bella giacca da ufficiale delle SS e, impercettibilmente, ci priva dei nostri vestiti civili e ci obbliga a indossarla; ci insegna il gergo militare, ci dà un grado e una responsabilità; ci porta con sé in Ucraina, ai piedi di un dirupo colmo di cadaveri di ebrei, e ci fa sparare alla nuca di una bella ragazza ancora agonizzante, e noi le spariamo per aiutarla a morire più in fretta, perché la sua bellezza ci ha colpiti e non possiamo tollerare che possa agonizzare tristemente così a lungo. Poi ce ne andiamo al circolo ufficiali, a bere del pessimo surrogato di the e a mangiare salsicce mal cotte, che subito vomiteremo in un lurido gabinetto, dove scopriremo, agghiacciando, che sconosciute mani di persone ridotte a oggetti fungono da carta igienica. Assisteremo incuriositi a cento massacri, a mille esecuzioni, cercando invano di carpire dagli occhi e dalle espressioni dei morituri quale sia il segreto del morire – e quindi quello del vivere. In seguito ci aggireremo spaventosamente indifferenti tra le macerie di Stalingrado, osservando il viso livido di soldati a un passo dalla morte, offrendo una sigaretta a un sergente che – ne siamo certi – non vedrà arrivare la prossima alba. Verremo colpiti – ci sembrerà una puntura di vespa, ma in realtà una pallottola ci ha attraversato il cranio –, e cominceremo a vivere una vita tra la realtà e il delirio, senza più riuscire a distinguerli nettamente. Si aprirà un terzo occhio in noi, che ci permetterà di scoprire, per esempio, le vere origini razziali del Füher; e sarà per questo che gli morderemo il naso quando vorrà appuntarci al petto la massima onorificenza della Germania nazista.
Il protagonista, insomma, ci fa entrare nella sua vita, e noi lettori – ancorché riluttanti e angosciati, stomacati e inorriditi – non potremo non identificarci in lui, pensare come lui. Alla fine saremo noi gli assassini, saremo noi i carnefici, e non potremo evitare di esserlo. Il narratore ha vinto la sua sfida, ormai siamo suoi fratelli, e la sua storia ci riguarda da vicino. Perché siamo ormai – come lui – divenuti gli abitanti di un mondo in cui la guerra ha privato i cittadini del loro diritto più importante: quello di non dover uccidere. E se ci guardiamo bene attorno, scopriremo che la guerra non è mai finita, si è solo trasformata. Con Anna Harendt eravamo arrivati a comprendere la banalità del male. Adottando il nichilismo, abbiamo tentato di trasformare il male in un totem, nell’illusoria speranza di renderlo benevolo. Lo stupefacente esordio narrativo di Jonathan Littell ci permette di comprendere – ma ci vuole molto, forse troppo, coraggio – che il male, anche quello indicibile, si può invece raccontare e comprendere per quello che davvero è, è stato e sarà. Il male assoluto esiste, e siamo solo noi uomini in grado di compierlo. Nessuna violenza è davvero disumana. Anche la più grande atrocità è, sia in sé che storicamente, solamente e semplicemente umana. E nessuna Furia diverrà mai davvero benevola – come ci ricorda, più che l’Orestea di Eschilo, l’Oreste di Euripide – ma ci perseguiterà sempre, e per sempre lo farà. È questo il destino degli uomini.
Tratto dalla rivista Humanitas 65 (3/2010) 524-527
(http://www.morcelliana.it/ita/MENU/Le_Riviste/Humanitas)
narrativa, seconda guerra mondiale, letteratura, nazismo, letteratura contemporanea, romanzi, letteratura moderna e contemporanea, moderna