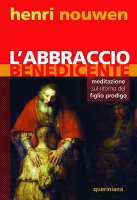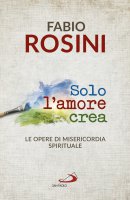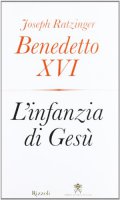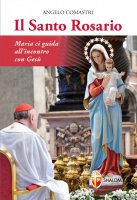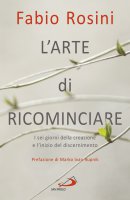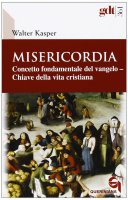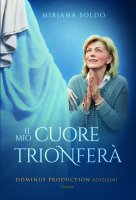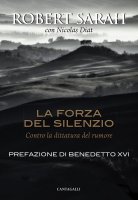Teologia
Dal greco theos (“dio”) e logos (“studio”, “discorso”, “dottrina”), il termine compare per la prima volta nel IV secolo a.C. negli scritti di Platone (Repubblica II, 379, 5-6), in un contesto critico riguardo ai discorsi mitici di poeti come Orfeo, Omero o Esiodo, comunemente considerati allora i primi 'teologi'.
Platone, prendendo le distanze da questi “mitologi” cerca di fondare la teologia come approccio razionale al problema di Dio. In Platone "theologia" indica un modo di “parlare di Dio” che in Aristotele diventerà addirittura il fine ultimo della ricerca filosofica intesa come riflessione sull’essere (la metafisica). L’evoluzione del significato del termine oscillerà costantemente fra una teologia “sacra” su base “rivelata”, concepita cioè come un discorso su Dio conforme alle Scritture (significato fissato dai Padri della Chiesa e dai dialettici del XII secolo), e la cosiddetta “teologia speculativa”, ovvero la conoscenza “scientifica” dei testi sacri, dei dogmi e della tradizione, nonché la sistematizzazione razionale dei dati della rivelazione.
Fino al XIII secolo la teologia si riferisce alla conoscenza di Dio, che è autentica solo se rimane legata alla vita spirituale. In questo senso, il “discorso su Dio” si conforma alla Scrittura e alla regola della fede. Al tempo stesso, il vero teologo deve coltivare la purificazione interiore, la contemplazione e rispettare il mistero di Dio.
La teologia assume poi lentamente il significato specifico di conoscenza organizzata e colta dei dati della rivelazione. Abelardo è stato uno dei primi a specificare questo termine, differenziandosi dal significato classico di una teologia vicina alla sua fonte religiosa o tendente alla mistica, secondo la direzione che gli aveva impresso nel V secolo lo Pseudo-Dionigi, l' Areopagita.
Solo nel XIII secolo, quindi, la teologia si orienta veramente verso il suo statuto “scientifico”, sotto l’impulso di Alberto Magno e del suo discepolo Tommaso d’Aquino, che aprono la teologia alla filosofia, soprattutto quella di Aristotele, tentando "vie" di conciliazione con il dogma cristiano.
Tommaso instaurerà così una nuova riflessione sulle relazioni fra la fede e la ragione, fra la teologia e la filosofia, che troverà il suo coronamento nella 'Summa theologiae' (1266-1272). La “teologia scolastica” fa in essa liberamente appello al portato della filosofia, basandosi al tempo stesso sulla fede e sulla “dottrina sacra”, segnando il passaggio alla teologia concepita come “scienza delle realtà divine”, significato che continua a valere fino ai nostri giorni. L’unità dei due aspetti della teologia (scritturale e razionale) si basa sul dato rivelato che solo la Scrittura, ispirata da Dio, consente di accedere è un autentico sapere e un vero discorso su Dio, in grado quindi di condurre a lui.
La teologia moderna ha tentato di comprendere il rapporto fra la doctrina sacra delle Scritture e un’interpretazione razionale delle stesse, dando luogo a un corpus di ricerche che attinge i suoi strumenti dalle scienze umane contemporanee (si pensi, uno per tutti, a Bultmann).
La teologia del XX secolo (Barth, Ebeling e Fuchs, Bonhoeffer, Niebuhr, von Balthasar, Congar, De Lubac, ma anche Moltmann, Pannenberg, Rahner, Metz, Schillebeeckx, Ratzinger, solo per nominare i più importanti) si è rinnovata considerevolmente, stimolata in questo dal movimento biblico, liturgico ed ecumenico, anche per rispondere alle questioni sollevate dai diversi approcci ai temi dell'uomo e del senso del mondo messi in cantiere dalla filosofia contemporanea e dalle scienze umane.
Platone, prendendo le distanze da questi “mitologi” cerca di fondare la teologia come approccio razionale al problema di Dio. In Platone "theologia" indica un modo di “parlare di Dio” che in Aristotele diventerà addirittura il fine ultimo della ricerca filosofica intesa come riflessione sull’essere (la metafisica). L’evoluzione del significato del termine oscillerà costantemente fra una teologia “sacra” su base “rivelata”, concepita cioè come un discorso su Dio conforme alle Scritture (significato fissato dai Padri della Chiesa e dai dialettici del XII secolo), e la cosiddetta “teologia speculativa”, ovvero la conoscenza “scientifica” dei testi sacri, dei dogmi e della tradizione, nonché la sistematizzazione razionale dei dati della rivelazione.
Fino al XIII secolo la teologia si riferisce alla conoscenza di Dio, che è autentica solo se rimane legata alla vita spirituale. In questo senso, il “discorso su Dio” si conforma alla Scrittura e alla regola della fede. Al tempo stesso, il vero teologo deve coltivare la purificazione interiore, la contemplazione e rispettare il mistero di Dio.
La teologia assume poi lentamente il significato specifico di conoscenza organizzata e colta dei dati della rivelazione. Abelardo è stato uno dei primi a specificare questo termine, differenziandosi dal significato classico di una teologia vicina alla sua fonte religiosa o tendente alla mistica, secondo la direzione che gli aveva impresso nel V secolo lo Pseudo-Dionigi, l' Areopagita.
Solo nel XIII secolo, quindi, la teologia si orienta veramente verso il suo statuto “scientifico”, sotto l’impulso di Alberto Magno e del suo discepolo Tommaso d’Aquino, che aprono la teologia alla filosofia, soprattutto quella di Aristotele, tentando "vie" di conciliazione con il dogma cristiano.
Tommaso instaurerà così una nuova riflessione sulle relazioni fra la fede e la ragione, fra la teologia e la filosofia, che troverà il suo coronamento nella 'Summa theologiae' (1266-1272). La “teologia scolastica” fa in essa liberamente appello al portato della filosofia, basandosi al tempo stesso sulla fede e sulla “dottrina sacra”, segnando il passaggio alla teologia concepita come “scienza delle realtà divine”, significato che continua a valere fino ai nostri giorni. L’unità dei due aspetti della teologia (scritturale e razionale) si basa sul dato rivelato che solo la Scrittura, ispirata da Dio, consente di accedere è un autentico sapere e un vero discorso su Dio, in grado quindi di condurre a lui.
La teologia moderna ha tentato di comprendere il rapporto fra la doctrina sacra delle Scritture e un’interpretazione razionale delle stesse, dando luogo a un corpus di ricerche che attinge i suoi strumenti dalle scienze umane contemporanee (si pensi, uno per tutti, a Bultmann).
La teologia del XX secolo (Barth, Ebeling e Fuchs, Bonhoeffer, Niebuhr, von Balthasar, Congar, De Lubac, ma anche Moltmann, Pannenberg, Rahner, Metz, Schillebeeckx, Ratzinger, solo per nominare i più importanti) si è rinnovata considerevolmente, stimolata in questo dal movimento biblico, liturgico ed ecumenico, anche per rispondere alle questioni sollevate dai diversi approcci ai temi dell'uomo e del senso del mondo messi in cantiere dalla filosofia contemporanea e dalle scienze umane.
Continua
Consigliati in questo reparto
I più venduti
Gesù di Nazaret vol. 3 - L'infanzia di Gesù
Benedetto XVI (Joseph Ratzinger)
(128 pag. - novembre 2012)
17,00 €
Gesù di Nazaret vol. 3 - L'infanzia di Gesù
Benedetto XVI (Joseph Ratzinger)
(128 pag. - novembre 2012)
17,00 €