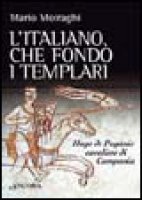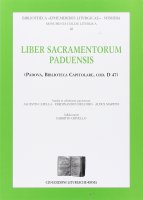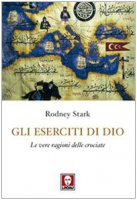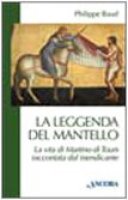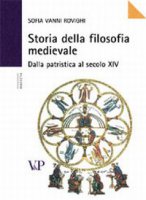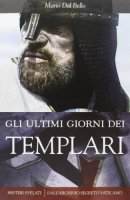Medioevo
II termine « medioevo » ha originariamente un significato spregiativo e poggia sulla teoria della decadenza cara agli umanisti, che videro nell'antichità l'ideale e nel proprio tempo la sua rinascita. Il periodo intermedio era ai loro occhi un'oscura barbarie. Il deprezzamento del medioevo fu ulteriormente aggravato dall'Illuminismo. Viceversa il romanticismo non solo lo riscoprì, ma inclinò persino a sopravvalutarlo. Pure la scienza storica del secolo XIX, spesso animata da un entusiasmo patrio, vi prestò grande attenzione e si sviluppò metodicamente soprattutto occupandosi di esso. I suoi risultati da un lato hanno messo in risalto i valori del medioevo, dall'altro hanno confutato certe idealizzazioni semplificatrici.
La storiografia laicista del XX secolo ha parlato di "secoli bui". Bui, nel senso di 'arretrati'. È questo un pregiudizio frutto di una operazione di mistificazione ideologica: si è voluto presentare il medioevo come un periodo di oscurantismo, perché risultasse più credibile l'immagine di uomo ateo progettata dalle ideologie materialiste. Il medioevo in realtà è l'età in cui più pervasivamente la fede ha formato l'esistenza della persona ed è diventata principio attivo di creazione di cultura e di civiltà.
Nel mondo antico la Chiesa aveva acquisito pian piano diritto di cittadinanza e il mondo medievale può essere considerato come plasmato da essa (in collaborazione con altri fattori). Il medioevo fu caratterizzato da uno stretto legame fra Chiesa e «Stato», fra spirituale e mondano, fra «imperium» e «sacerdotium». Di conseguenza, a seconda dei punti di osservazione, fu considerato dagli storici o una condizione ideale o un periodo di grande confusione. La storia della Chiesa deve tener conto del concorso delle molte forze in campo e rendere intelligibile il passato. Deve astenersi da giudizi sommari, che non rendono giustizia alla realtà.
Nel medioevo, lo spazio vitale della Chiesa non è più costituito dal Mediterraneo, bensì dalla sua costa settentrionale e dal relativo hinterland. Ciò fu il risultato delle perdite subite in favore dell'islam e della missione presso i germani e gli slavi. Verso il 700 esso dovette essere difeso sia in oriente che in occidente: Costantinopoli riuscì ad affermarsi e difese contemporaneamente l'occidente. Qui gli arabi, dopo essere entrati in Spagna (711), distrussero il regno dei visigoti e superarono i Pirenei. Con la vittoria di Carlo Martello a Tours e a Poitiers nel 732 la loro avanzata ebbe termine; poi, con l'offensiva di Carlo Magno, essi furono respinti sino all'Ebro. Degli stati germanici presenti sull'ex territorio dell'impero romano sussistevano ancora il regno franco, quello longobardo e quello anglosassone. Promettente si rivelò soprattutto il regno franco, ove i carolingi, in qualità di maestri di palazzo con potere su tutto il regno (a partire dal 687), divennero la forza politica più importante dell'occidente.
La suddivisione cronologica del medioevo non è facile. Per quanto riguarda l'inizio, si pensò alla deposizione dell'ultimo imperatore romano d'occidente (476), al battesimo di Clodoveo (498 ca.) o ad eventi posteriori. Nel saggio ormai classico pubblicato nel 1957 "Modernus e altre idee del tempo nel Medioevo" lo storico e filologo tedesco Walter Freund giunge a retrodatare la comparsa del termine 'modernus' all'epistolario di papa Gelasio, e precisamente al 494. Il neologismo di Gelasio, che allude alle condizioni del cristianesimo nei 'modernis seculis', rimane senza specifica spiegazione: come se i suoi interlocutori dovessero afferrarne facilmente la semantica. Freund, cercando la contestualizzazione del referente più probabile, lo individua nella coscienza del cristianesimo di aver inaugurato un nuovo ordine storico, chiudendo l'epoca antica. Il collegamento tra germanesimo, antichità e cristianesimo rimane comunque distintivo del medioevo: l'iniziativa missionaria nei confronti degli Anglosassoni continentali e non influenzerà in maniera determinante la Chiesa e il mondo occidentale. La conclusione del medioevo è stata vista come incipiente negli sviluppi culturali del secolo XIII, compiuta nell'umanesimo ed acquisita nel primo rinascimento, con la conclusione dei concili riformistici (1449) e l'inizio della riforma protestante. Le date del 1517 (entrata in scena di Luterò contro le indulgenze) e del 1492 (scoperta dell'America) offrono il vantaggio di essere quelle più usate nella storia universale. Inizio e fine vanno intesi come periodi piuttosto estesi, durante i quali qualcosa del vecchio scompare e si affacciano nuove realtà. Come al medioevo si è fatto precedere uno specifico « periodo delle migrazioni dei popoli », così lo si potrebbe far seguire da un periodo caratterizzato da eventi di secolarizzazione, che va dal secolo XIII al XVII. Ogni articolazione riesce comunque ad includere solo determinati settori o paesi e corrisponde in misura modesta alla multiformità del processo storico.
Per l'ulteriore suddivisione tra Alto e Basso Medioevo c'è chi ha indicato l'intervento di Enrico III nella confusa situazione romana del 1046, la fine della casa degli Hohenstaufen (1268), l'elezione di Gregorio X (1271). Questi eventi sono il segnale di importanti cambiamenti nella Chiesa e nel mondo e delimitano tre periodi: quello dell'alto medioevo, contraddistinto dalla missione, dal rapporto della Chiesa col regno dei franchi e con l'impero, quello del basso medioevo contraddistinto dalla « riforma della Chiesa » e dalle sue conseguenze, e quello del tardo medioevo, caratterizzato dalla divaricazione fra le esigenze della Chiesa e quelle di un mondo in forte mutazione.
La storiografia laicista del XX secolo ha parlato di "secoli bui". Bui, nel senso di 'arretrati'. È questo un pregiudizio frutto di una operazione di mistificazione ideologica: si è voluto presentare il medioevo come un periodo di oscurantismo, perché risultasse più credibile l'immagine di uomo ateo progettata dalle ideologie materialiste. Il medioevo in realtà è l'età in cui più pervasivamente la fede ha formato l'esistenza della persona ed è diventata principio attivo di creazione di cultura e di civiltà.
Nel mondo antico la Chiesa aveva acquisito pian piano diritto di cittadinanza e il mondo medievale può essere considerato come plasmato da essa (in collaborazione con altri fattori). Il medioevo fu caratterizzato da uno stretto legame fra Chiesa e «Stato», fra spirituale e mondano, fra «imperium» e «sacerdotium». Di conseguenza, a seconda dei punti di osservazione, fu considerato dagli storici o una condizione ideale o un periodo di grande confusione. La storia della Chiesa deve tener conto del concorso delle molte forze in campo e rendere intelligibile il passato. Deve astenersi da giudizi sommari, che non rendono giustizia alla realtà.
Nel medioevo, lo spazio vitale della Chiesa non è più costituito dal Mediterraneo, bensì dalla sua costa settentrionale e dal relativo hinterland. Ciò fu il risultato delle perdite subite in favore dell'islam e della missione presso i germani e gli slavi. Verso il 700 esso dovette essere difeso sia in oriente che in occidente: Costantinopoli riuscì ad affermarsi e difese contemporaneamente l'occidente. Qui gli arabi, dopo essere entrati in Spagna (711), distrussero il regno dei visigoti e superarono i Pirenei. Con la vittoria di Carlo Martello a Tours e a Poitiers nel 732 la loro avanzata ebbe termine; poi, con l'offensiva di Carlo Magno, essi furono respinti sino all'Ebro. Degli stati germanici presenti sull'ex territorio dell'impero romano sussistevano ancora il regno franco, quello longobardo e quello anglosassone. Promettente si rivelò soprattutto il regno franco, ove i carolingi, in qualità di maestri di palazzo con potere su tutto il regno (a partire dal 687), divennero la forza politica più importante dell'occidente.
La suddivisione cronologica del medioevo non è facile. Per quanto riguarda l'inizio, si pensò alla deposizione dell'ultimo imperatore romano d'occidente (476), al battesimo di Clodoveo (498 ca.) o ad eventi posteriori. Nel saggio ormai classico pubblicato nel 1957 "Modernus e altre idee del tempo nel Medioevo" lo storico e filologo tedesco Walter Freund giunge a retrodatare la comparsa del termine 'modernus' all'epistolario di papa Gelasio, e precisamente al 494. Il neologismo di Gelasio, che allude alle condizioni del cristianesimo nei 'modernis seculis', rimane senza specifica spiegazione: come se i suoi interlocutori dovessero afferrarne facilmente la semantica. Freund, cercando la contestualizzazione del referente più probabile, lo individua nella coscienza del cristianesimo di aver inaugurato un nuovo ordine storico, chiudendo l'epoca antica. Il collegamento tra germanesimo, antichità e cristianesimo rimane comunque distintivo del medioevo: l'iniziativa missionaria nei confronti degli Anglosassoni continentali e non influenzerà in maniera determinante la Chiesa e il mondo occidentale. La conclusione del medioevo è stata vista come incipiente negli sviluppi culturali del secolo XIII, compiuta nell'umanesimo ed acquisita nel primo rinascimento, con la conclusione dei concili riformistici (1449) e l'inizio della riforma protestante. Le date del 1517 (entrata in scena di Luterò contro le indulgenze) e del 1492 (scoperta dell'America) offrono il vantaggio di essere quelle più usate nella storia universale. Inizio e fine vanno intesi come periodi piuttosto estesi, durante i quali qualcosa del vecchio scompare e si affacciano nuove realtà. Come al medioevo si è fatto precedere uno specifico « periodo delle migrazioni dei popoli », così lo si potrebbe far seguire da un periodo caratterizzato da eventi di secolarizzazione, che va dal secolo XIII al XVII. Ogni articolazione riesce comunque ad includere solo determinati settori o paesi e corrisponde in misura modesta alla multiformità del processo storico.
Per l'ulteriore suddivisione tra Alto e Basso Medioevo c'è chi ha indicato l'intervento di Enrico III nella confusa situazione romana del 1046, la fine della casa degli Hohenstaufen (1268), l'elezione di Gregorio X (1271). Questi eventi sono il segnale di importanti cambiamenti nella Chiesa e nel mondo e delimitano tre periodi: quello dell'alto medioevo, contraddistinto dalla missione, dal rapporto della Chiesa col regno dei franchi e con l'impero, quello del basso medioevo contraddistinto dalla « riforma della Chiesa » e dalle sue conseguenze, e quello del tardo medioevo, caratterizzato dalla divaricazione fra le esigenze della Chiesa e quelle di un mondo in forte mutazione.
Continua
Consigliati in questo reparto
I più venduti
Liber sacramentorum paduensis
52,00 € → 49,40 €
A. Catella – F. Dell'oro – A. Martini
CLV Edizioni Centro Liturgico Vincenziano
(596 pag. - gennaio 2005)
Sconto 5%
Dire Dio. Linguaggio sponsale e materno nella...
22,00 € → 20,90 €
(368 pag. - gennaio 2006)
Sconto 5%
Roberto Grossatesta. La filosofia della luce
12,00 € → 11,40 €
ESD Edizioni Studio Domenicano
(208 pag. - maggio 2007)
Sconto 5%
Liber sacramentorum paduensis
52,00 € → 49,40 €
A. Catella – F. Dell'oro – A. Martini
CLV Edizioni Centro Liturgico Vincenziano
(596 pag. - gennaio 2005)
Sconto 5%
Dire Dio. Linguaggio sponsale e materno nella...
22,00 € → 20,90 €
(368 pag. - gennaio 2006)
Sconto 5%