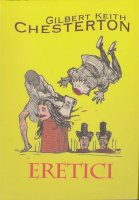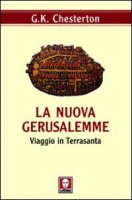PREFAZIONE
di Sabina Nicolini
Esistono al giorno d'oggi manuali d'ogni specie, che ci istruiscono intono ad una serie di attività di tutto rispetto e di considerevole impegno. Manuali di cucina, di trekking, di bricolage per la casa. Per non parlare della navigazione a vela o dell'arrampicata libera. Attività tutte che — diciamolo subito — Gilbert K. Chesterton non si sarebbe mai sognato di intraprendere, essendo, per sua definizione, la persona più pigra di sua conoscenza.
Eppure anch'egli, con i suoi saggi — che altro non sono se non quegli articoli che cominciarono a scoppiettare ad inizio secolo sui giornali inglesi come fuochi d'artificio o tuoni di cannone — propone al lettore un particolare addestramento che può essere paragonato proprio ad un esercizio fisico. Nella sua prefazione a Tremendous Trifles (1909), da cui sono tratte molte delle serissime storie che seguono, Chesterton raccomanda: «Teniamo l'occhio in esercizio fino a quando impara a vedere le realtà sensazionali che corrono attraverso il campo visivo, cioè quelle ordinarie come una staccionata dipinta. Diventiamo atleti oculari. Impariamo a scrivere saggi su un gatto randagio o una nuvola colorata. Ho provato a fare una cosa del genere in quanto segue, ma chiunque altro potrebbe farlo meglio, se solo ci provasse». Un manuale, insomma, per imparare a vedere. Che resta, tra le mille imprese mirabolanti dell'uomo, quella più temeraria.
Perché per vedere occorre tornare alle cose, le cose quotidiane, banali, quelle che hanno cessato non solo di stupirci — perché occorrerebbe essere dei bambini o dei mistici per poterlo fare — quanto di far partire i nostri ragionamenti, di offrire loro il solido appoggio di due gambe. Così che le nostre idee risultano in molti casi, come si dice, campate in aria. Le idee di Chesterton partono invece dall'osservazione di una serie di oggetti di capitale importanza: biglietti del tram, gessetti colorati, teatrini giocattolo, pezzi di formaggio e nuvole grigie.
Tra questi oggetti egli ci conduce come in un giardino incantato, per rinverdire nel nostro sguardo la meraviglia per qualcosa di unico e prezioso, qualcosa che esiste ma che abbiamo rischiato di perdere, qualcosa che non appassisce, perché possiede in sé la potenza di un miracolo: se tutte le cose rimangono quali erano, è perché sono sempre nuove. Gli uomini si affaticano per delle novità, ma sono le cose vecchie che stupiscono e colpiscono profondamente; sono le cose vecchie veramente giovani.
Ci potremmo chiedere quali occhiali indossi Chesterton per cantare questa giovinezza, esaltando perfino lo splendore tutto speciale delle giornate grigie. Sono forse gli occhiali di un pazzo, o di un un inguaribile ottimista? No, ma piuttosto gli occhi di un uomo che non ha mai rinunciato ad essere vivo, da quando è stato liberato dalla morte. Il suo nome è Lazzaro, perché egli ha conosciuto l'oscurità del sepolcro. A modo suo, egli è un mistico, perché ha visto "l'altro lato" della realtà. Si è lasciato avvicinare dal Mistero, l'ha accolto come compagno dell'esistenza, ed è stata la scelta più temeraria ma anche più ragionevole che potesse compiere, perché tutto il segreto del misticismo è questo: l'uomo può capir tutto con l'aiuto di quello che non capisce.
Chesterton ci dà continuamente l'impressione di aver capito tutto. O di trovarsi costantemente avanti a noi di almeno un passo — ed è in fondo l'andatura di ogni profeta, a cui è dischiusa una particolare e brillantissima intuizione dei segni dei tempi. Ma è alla maniera di Giobbe che Chesterton è potuto pervenire alla luce, alla maniera di un uomo che ha sofferto quelle malattie dello spirito moderno che sono lo scetticismo e l'agnosticismo di una ragione imprigionata.
Come Giobbe, però, è riuscito ad aprire gli occhi davanti alla Presenza di un Altro, che abbatte le mura della prigione: Ora i miei occhi ti vedono. Presenza sicura, anche se invisibile, e invisibile non perché oscura, ma perché abbagliante. Ci sono cose troppo grandi per essere viste, e cose troppo semplici per essere dette: è l'esperienza con cui Chesterton legge l'avvicinarsi dei Magi a Betlemme, dove il Mistero si è fatto semplice e vicino, per irradiare la sua luce su tutte le cose. "Vediamo", allora, perché siamo raggiunti dall'Essere nella sua luminosità, che entra per la fede nei nostri occhi.
E la freschezza delle "cose banali" affonda il suo segreto nell'origine delle cose stesse, nel Creatore che ha lasciato in un angolo del grande dipinto la sua firma. C'è una novità che "cova" dentro le cose, che attende di essere dischiusa rompendo l'inganno della consuetudine appunto per comunicare il Mistero, ed operare così una trasformazione fino a quel momento insospettabile.
È la trasformazione, che ha tutto il sapore del miracolo, a cui le fiabe ci terrebbero sempre desti, se solo non avessimo smesso di leggerle, se la nonna del drago fosse ancora una presenza familiare prima di addormentarci. Perché le fiabe restano nel nostro mondo insano come baluardo del senso comune, roccaforte delle virtù, antidoto alle paure, deposito di quella gratitudine e di quello stupore per la vita che ci fanno rinascere ogni giorno.
Questi saggi, nei quali i grandi temi della nostra e di ogni epoca si rincorrono con gustosa ironia e audace provocazione, assomigliano per la loro potenza a quelle storie che ci hanno fatto diventare grandi. Alcuni assolutamente inediti in Italia, altri assenti dalle librerie da cinquant'anni, possono continuare oggi a farci crescere nell'arte di vedere, pensare e vivere. E, perché no, farci prendere quella libertà quella libertà davvero speciale, che solo gli uomini davvero Vivi hanno di dipingere sui soffitti, vivere avventure nel giardino di casa, propagandare idee politicamente scorrette, perseguire le virtù, credere in Dio e raccontarlo di nuovo al mondo.
ESTRATTO DAL PRIMO CAPITOLO
UN PEZZO DI GESSO
Ricordo una mattina splendida d'estate, tutta blu e argento, quando mi strappai con riluttanza alla mansione di non fare nulla di particolare, infilai un cappello malconcio, presi il bastone da passeggio e mi ficcai in tasca sei gessetti dai colori brillanti. Poi andai nella cucina (che, come tutto il resto della casa, apparteneva ad una vecchia signora robusta e piena di buon senso di un paesino del Sussex), e chiesi alla proprietaria e occupante della cucina se avesse della carta scura da pacchi. Ne aveva in gran quantità, anzi, ne aveva fin troppa, e fraintese lo scopo e la ragione effettiva dell'esistenza di questo genere di carta.
Sembrava pensare che se una persona volesse della carta da pacchi avesse l'intenzione di confezionarci dei pacchi, che era l'ultima cosa che io avevo in mente di fare; in verità, è una cosa che ho scoperto essere al di là di ogni mia capacità mentale. Da qui si dilungava parecchio sulle diverse qualità di robustezza e resistenza del materiale. Le spiegai che io volevo soltanto farci dei disegni sopra, che non pretendevo affatto che durassero in eterno, e che quindi, dal mio punto di vista, non era questione di consistenza, ma di superficie rispondente allo scopo, cosa in confronto irrilevante per un pacco. Quando capì che io volevo disegnare si offrì di riempirmi di carta da lettera, supponendo forse che io scrivessi i miei appunti e la corrispondenza su vecchi involucri di carta da pacchi per fare economia.
A quel punto provai a chiarire la sottile sfumatura logica, per cui a me non solo piaceva la carta da pacchi, ma quella particolare qualità bruna della carta, proprio come mi piace il bruno dei boschi di ottobre, o della birra, o dei ruscelli di torba del Nord.