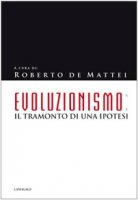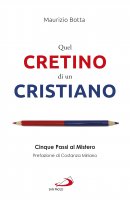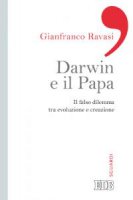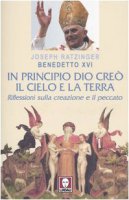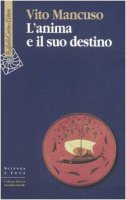Scienza e fede
Consigliati in questo reparto
I più venduti
Tutti i libri del reparto «Scienza e fede»

Libro
EAN 9788849886146 |
di Costantino Di Bruno, Francesco Cicione | -
Rubbettino Editore
(luglio 2025)
Normalmente disponibile in 15/16 giorni lavorativi
25,00 € →
23,75 €
È sufficiente una prospettiva scientifica, tecnologica, antropologica, sociologica, storica, umanistica e filosofica per penetrare il "mistero…
|
|

Libro
EAN 9791256145195 |
di Marco Salvati | -
Castelvecchi
(luglio 2025)
Normalmente disponibile in 15/16 giorni lavorativi
18,50 € →
17,57 €
La fisica assume una realtà fatta interamente di “cose” materiali in interazione tra loro. Come conciliare questa visione,…
|
|

Libro
EAN 9788879874526 |
di Giuseppe La Naia | -
Centro Editoriale Valtortiano
(giugno 2025)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
14,00 € →
13,30 €
“Un viaggio tra fede e scienza con gli scritti di Maria Valtorta. L’Evoluzionismo e il Creatore raccoglie riflessioni profonde su…
|
|

Libro
EAN 9788863622775 |
di Giorgio Ricci | -
Chirico
(giugno 2025)
Normalmente disponibile in 8/9 giorni lavorativi
15,00 €
Leggere questo libro mi ha fatto bene due volte. A parte l'amicizia con Giorgio, e l'amore e la stima per Carmen, mia catechista, che ho…
|
|

Libro
EAN 9791259626639 |
di Cristiano Ceresani | -
Cantagalli Edizioni
(giugno 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
15,00 € →
14,25 €
Può un'Intelligenza Artificiale aiutarci a riscoprire Dio?
Tra fede e ragione, trascendenza e modernità, questo libro ci offre un confronto…
|
|

Libro
EAN 9791259625809 |
di Francesco Iappelli | -
Cantagalli Edizioni
(aprile 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
18,00 € →
17,10 €
Questo studio, quasi un esercizio ludico, ha coinvolto molti docenti che hanno aiutato l'autore nella sua ricerca. Alcuni atei, ma non per…
|
|

Libro
EAN 9788860996138 |
di Claudia Fanti | -
Gabrielli Editori
(aprile 2025)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
17,00 € →
16,15 €
Giunti sull'orlo dell'abisso ecologico e climatico, solo una rivoluzione spirituale potrà salvarci, richiamandoci a casa, sul nostro pianeta.…
|
|

Libro
EAN 9791222318042 |
Mimesis
(marzo 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
12,00 € →
11,40 €
Che cos’è la realtà? Quanto davvero possiamo conoscerla? Un viaggio tra filosofia, scienza e teologia affronta questi…
|
|

Libro
EAN 9788839938305 |
di Stefano Visintin | -
Queriniana Edizioni
(marzo 2025)
Disponibilità immediata
9,00 € →
8,55 €
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), geologo e paleontologo di fama mondiale, è una delle figure più affascinanti della cultura cattolica…
|
|

Libro
EAN 9791254942338 |
Baldini Castoldi Dalai
(febbraio 2025)
Normalmente disponibile in 15/16 giorni lavorativi
16,00 € →
15,20 €
Questo libro racconta come si è evoluta la nostra visione scientifica del mondo e, con essa, la capacità di leggere il cielo.…
|
|

Libro
EAN 9788892871861 |
di Salvino Leone | -
Il Pozzo di Giacobbe
(febbraio 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
18,00 € →
17,10 €
Tutto ciò che è accaduto dal Gethsemani alla sepoltura di Gesù. Un libro rigoroso sul piano scientifico, storico, esegetico, ma al tempo…
|
|

Libro
EAN 9788826609317 |
di Vincenzo Balzani, Erio Castellucci | -
Libreria Editrice Vaticana
(novembre 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
15,00 € →
14,25 €
Saggio scritto da uno scienziato di fama internazionale e dai uno dei teologi italiani piu? noti sul tema della cura dell'ecologia e…
|
|

Libro
EAN 9788838254802 |
Studium
(ottobre 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
26,00 € →
24,70 €
Questo volume raccoglie diversi scritti (comprese alcune lettere) del Cardinale Paul Poupard su Scienza & Fede. Di formazione storica ma…
|
|

Libro
EAN 9788892871632 |
di Roberto G. Timossi | -
Il Pozzo di Giacobbe
(ottobre 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
18,00 € →
17,10 €
Dimostrare l'esistenza di Dioe? possibile, ecco le prove. Il bisogno di Assoluto e? radicato in ogni animo umano come propensione…
|
|

Libro
EAN 9788804791058 |
di Federico Faggin | -
Mondadori
(giugno 2024)
Disponibilità immediata
22,00 € →
20,90 €
Federico Faggin, un nome che riecheggia nella storia dell'innovazione tecnologica. Inventore del microchip e del touchscreen, Faggin non…
|
|

Libro
EAN 9788869580420 |
di Margherita Hack, Pierluigi Di Piazza | -
Nuovadimensione
(giugno 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
12,90 € →
12,25 €
Una scienziata atea e un prete di frontiera sempre pronto a lottare dalla parte dei più deboli si interrogano sui valori fondamentali…
|
|
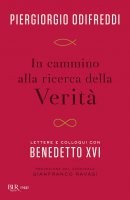
Libro
EAN 9788817186766 |
di Piergiorgio Odifreddi, Benedetto XVI (Joseph Ratzinger) | -
BUR Biblioteca Univ. Rizzoli
(aprile 2024)
Disponibilità immediata
13,00 € →
12,35 €
Un percorso spirituale in cui il teologo e lo scienziato si confrontano su numerosi temi: l’etica, l’antropologia, la…
|
|

Libro
EAN 9788892244030 |
di Rino Fisichella | -
San Paolo Edizioni
(marzo 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
25,00 € →
23,75 €
Dio e/o Galileo? Da questa domanda fondamentale che si protrae da secoli, ponendo scienza e fede in contrapposizione, prende le mosse il…
|
|

Libro
EAN 9791222306872 |
Mimesis
(marzo 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
12,00 € →
11,40 €
Attraverso vari contributi l’opera rintraccia il fondo concettuale del transumanesimo. Una corrente di pensiero che, tramite la continua…
|
|
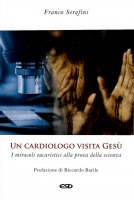
Libro
EAN 9788855450911 |
di Franco Serafini | -
ESD Edizioni Studio Domenicano
(marzo 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
23,00 € →
21,85 €
Negli ultimi anni 5 miracoli eucaristici sono stati oggetto di sofisticate indagini scientifiche. Le migliori tecnologie, proprio quelle che…
|
|

Libro
EAN 9788872242353 |
di Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonnassies | -
Sonda
(febbraio 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
24,90 € →
23,65 €
Per quasi cinque secoli si sono accumulate scoperte scientifiche che hanno suggerito che fosse possibile spiegare l’Universo senza la…
|
|
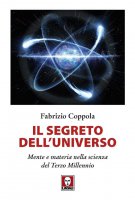
Libro
EAN 9791255840312 |
di Fabrizio Coppola | -
Lindau Edizioni
(ottobre 2023)
Normalmente disponibile in 15/16 giorni lavorativi
28,00 € →
26,60 €
Le scoperte della scienza sembrano in contrasto con la visione tradizionale insegnata dalla religione. Ne consegue una «doppia…
|
|
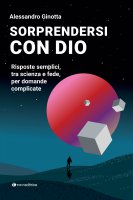
Libro
EAN 9791259751805 |
di Alessandro Ginotta | -
Tau Editrice
(dicembre 2022)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
15,00 € →
14,25 €
Creazione o evoluzione? Com'è nata la vita nell'Universo? Esiste l'Aldilà? In "Sorprendersi con Dio" troverai le risposte a queste e a tante…
|
|
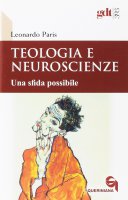
Libro
EAN 9788839908933 |
di Leonardo Paris | -
Queriniana Edizioni
(settembre 2022)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
23,00 € →
21,85 €
Le neuroscienze, studiando il cervello e il suo funzionamento, finiscono per invadere ambiti di pertinenza di altri saperi. Attraverso…
|
|
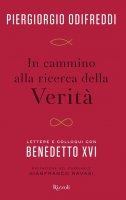
Libro
EAN 9788817164870 |
di Piergiorgio Odifreddi, Benedetto XVI | -
Rizzoli
(maggio 2022)
Normalmente disponibile in 15/16 giorni lavorativi
18,50 € →
17,57 €
La voce di Dio e quella della Ragione si alternano in un libro unico offrendo a tutti formidabili spunti di riflessione sul senso della…
|
|

Libro
EAN 9788857588421 |
di Francesco Massobrio | -
Mimesis
(maggio 2022)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
22,00 € →
20,90 €
Cosa succederebbe se, ripercorrendo la nascita della scienza moderna e il contributo che ha dato al cambiamento dell'immagine dell'uomo, del…
|
|
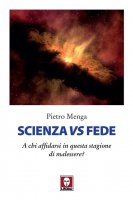
Libro
EAN 9788833537900 |
di Pietro Menga | -
Lindau Edizioni
(aprile 2022)
Normalmente disponibile in 15/16 giorni lavorativi
24,00 € →
22,80 €
La concezione del mondo e della vita tradizionalmente proposta dalla religione, che comprendeva il trascendente, tutta la conoscenza, le…
|
|
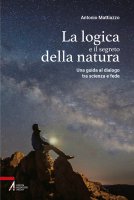
Libro
EAN 9788825054156 |
di Mons. Antonio Mattiazzo | -
Edizioni Messaggero
(aprile 2022)
Disponibilità immediata
15,00 € →
14,25 €
Sempre più il rapporto tra scienza e fede-filosofia suscita domande soprattutto nei giovani che si affacciano alla vita e cercano risposte…
|
|

Libro
EAN 9788860994882 |
di Luigi Secco | -
Gabrielli Editori
(marzo 2022)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
18,00 € →
17,10 €
Come il Maestro Nicolò Dallaporta ci ha insegnato, ci sono "due occhi" per guardare al Reale: la Scienza e la Trascendenza. Si tratta di due…
|
|
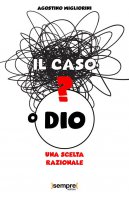
Libro
EAN 9788885589681 |
di Agostino Migliorini | -
Sempre Editore
(marzo 2022)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
14,00 € →
13,30 €
Da dove ha origine l'universo e le leggi che lo regolano? Come è nato l'uomo e cosa lo distingue dagli animali? Perché avvengono…
|
|

Libro
EAN 9788849886146 |
di Costantino Di Bruno, Francesco Cicione | -
Rubbettino Editore
(luglio 2025)
Normalmente disponibile in 15/16 giorni lavorativi
25,00 € →
23,75 €
È sufficiente una prospettiva scientifica, tecnologica, antropologica, sociologica, storica, umanistica e filosofica per penetrare il "mistero…
|
|

Libro
EAN 9791256145195 |
di Marco Salvati | -
Castelvecchi
(luglio 2025)
Normalmente disponibile in 15/16 giorni lavorativi
18,50 € →
17,57 €
La fisica assume una realtà fatta interamente di “cose” materiali in interazione tra loro. Come conciliare questa visione,…
|
|

Libro
EAN 9788879874526 |
di Giuseppe La Naia | -
Centro Editoriale Valtortiano
(giugno 2025)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
14,00 € →
13,30 €
“Un viaggio tra fede e scienza con gli scritti di Maria Valtorta. L’Evoluzionismo e il Creatore raccoglie riflessioni profonde su…
|
|

Libro
EAN 9788863622775 |
di Giorgio Ricci | -
Chirico
(giugno 2025)
Normalmente disponibile in 8/9 giorni lavorativi
15,00 €
Leggere questo libro mi ha fatto bene due volte. A parte l'amicizia con Giorgio, e l'amore e la stima per Carmen, mia catechista, che ho…
|
|

Libro
EAN 9791259626639 |
di Cristiano Ceresani | -
Cantagalli Edizioni
(giugno 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
15,00 € →
14,25 €
Può un'Intelligenza Artificiale aiutarci a riscoprire Dio?
Tra fede e ragione, trascendenza e modernità, questo libro ci offre un confronto…
|
|

Libro
EAN 9791259625809 |
di Francesco Iappelli | -
Cantagalli Edizioni
(aprile 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
18,00 € →
17,10 €
Questo studio, quasi un esercizio ludico, ha coinvolto molti docenti che hanno aiutato l'autore nella sua ricerca. Alcuni atei, ma non per…
|
|

Libro
EAN 9788860996138 |
di Claudia Fanti | -
Gabrielli Editori
(aprile 2025)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
17,00 € →
16,15 €
Giunti sull'orlo dell'abisso ecologico e climatico, solo una rivoluzione spirituale potrà salvarci, richiamandoci a casa, sul nostro pianeta.…
|
|

Libro
EAN 9791222318042 |
Mimesis
(marzo 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
12,00 € →
11,40 €
Che cos’è la realtà? Quanto davvero possiamo conoscerla? Un viaggio tra filosofia, scienza e teologia affronta questi…
|
|

Libro
EAN 9788839938305 |
di Stefano Visintin | -
Queriniana Edizioni
(marzo 2025)
Disponibilità immediata
9,00 € →
8,55 €
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), geologo e paleontologo di fama mondiale, è una delle figure più affascinanti della cultura cattolica…
|
|

Libro
EAN 9791254942338 |
Baldini Castoldi Dalai
(febbraio 2025)
Normalmente disponibile in 15/16 giorni lavorativi
16,00 € →
15,20 €
Questo libro racconta come si è evoluta la nostra visione scientifica del mondo e, con essa, la capacità di leggere il cielo.…
|
|

Libro
EAN 9788892871861 |
di Salvino Leone | -
Il Pozzo di Giacobbe
(febbraio 2025)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
18,00 € →
17,10 €
Tutto ciò che è accaduto dal Gethsemani alla sepoltura di Gesù. Un libro rigoroso sul piano scientifico, storico, esegetico, ma al tempo…
|
|

Libro
EAN 9788826609317 |
di Vincenzo Balzani, Erio Castellucci | -
Libreria Editrice Vaticana
(novembre 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
15,00 € →
14,25 €
Saggio scritto da uno scienziato di fama internazionale e dai uno dei teologi italiani piu? noti sul tema della cura dell'ecologia e…
|
|

Libro
EAN 9788838254802 |
Studium
(ottobre 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
26,00 € →
24,70 €
Questo volume raccoglie diversi scritti (comprese alcune lettere) del Cardinale Paul Poupard su Scienza & Fede. Di formazione storica ma…
|
|

Libro
EAN 9788892871632 |
di Roberto G. Timossi | -
Il Pozzo di Giacobbe
(ottobre 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
18,00 € →
17,10 €
Dimostrare l'esistenza di Dioe? possibile, ecco le prove. Il bisogno di Assoluto e? radicato in ogni animo umano come propensione…
|
|

Libro
EAN 9788804791058 |
di Federico Faggin | -
Mondadori
(giugno 2024)
Disponibilità immediata
22,00 € →
20,90 €
Federico Faggin, un nome che riecheggia nella storia dell'innovazione tecnologica. Inventore del microchip e del touchscreen, Faggin non…
|
|

Libro
EAN 9788869580420 |
di Margherita Hack, Pierluigi Di Piazza | -
Nuovadimensione
(giugno 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
12,90 € →
12,25 €
Una scienziata atea e un prete di frontiera sempre pronto a lottare dalla parte dei più deboli si interrogano sui valori fondamentali…
|
|
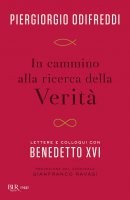
Libro
EAN 9788817186766 |
di Piergiorgio Odifreddi, Benedetto XVI (Joseph Ratzinger) | -
BUR Biblioteca Univ. Rizzoli
(aprile 2024)
Disponibilità immediata
13,00 € →
12,35 €
Un percorso spirituale in cui il teologo e lo scienziato si confrontano su numerosi temi: l’etica, l’antropologia, la…
|
|

Libro
EAN 9788892244030 |
di Rino Fisichella | -
San Paolo Edizioni
(marzo 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
25,00 € →
23,75 €
Dio e/o Galileo? Da questa domanda fondamentale che si protrae da secoli, ponendo scienza e fede in contrapposizione, prende le mosse il…
|
|

Libro
EAN 9791222306872 |
Mimesis
(marzo 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
12,00 € →
11,40 €
Attraverso vari contributi l’opera rintraccia il fondo concettuale del transumanesimo. Una corrente di pensiero che, tramite la continua…
|
|
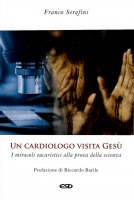
Libro
EAN 9788855450911 |
di Franco Serafini | -
ESD Edizioni Studio Domenicano
(marzo 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
23,00 € →
21,85 €
Negli ultimi anni 5 miracoli eucaristici sono stati oggetto di sofisticate indagini scientifiche. Le migliori tecnologie, proprio quelle che…
|
|

Libro
EAN 9788872242353 |
di Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonnassies | -
Sonda
(febbraio 2024)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
24,90 € →
23,65 €
Per quasi cinque secoli si sono accumulate scoperte scientifiche che hanno suggerito che fosse possibile spiegare l’Universo senza la…
|
|
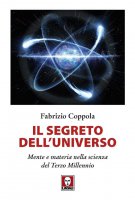
Libro
EAN 9791255840312 |
di Fabrizio Coppola | -
Lindau Edizioni
(ottobre 2023)
Normalmente disponibile in 15/16 giorni lavorativi
28,00 € →
26,60 €
Le scoperte della scienza sembrano in contrasto con la visione tradizionale insegnata dalla religione. Ne consegue una «doppia…
|
|
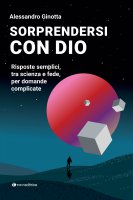
Libro
EAN 9791259751805 |
di Alessandro Ginotta | -
Tau Editrice
(dicembre 2022)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
15,00 € →
14,25 €
Creazione o evoluzione? Com'è nata la vita nell'Universo? Esiste l'Aldilà? In "Sorprendersi con Dio" troverai le risposte a queste e a tante…
|
|
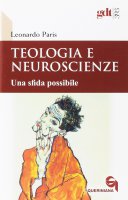
Libro
EAN 9788839908933 |
di Leonardo Paris | -
Queriniana Edizioni
(settembre 2022)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
23,00 € →
21,85 €
Le neuroscienze, studiando il cervello e il suo funzionamento, finiscono per invadere ambiti di pertinenza di altri saperi. Attraverso…
|
|
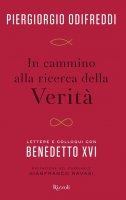
Libro
EAN 9788817164870 |
di Piergiorgio Odifreddi, Benedetto XVI | -
Rizzoli
(maggio 2022)
Normalmente disponibile in 15/16 giorni lavorativi
18,50 € →
17,57 €
La voce di Dio e quella della Ragione si alternano in un libro unico offrendo a tutti formidabili spunti di riflessione sul senso della…
|
|

Libro
EAN 9788857588421 |
di Francesco Massobrio | -
Mimesis
(maggio 2022)
Disponibile in 20/21 giorni lavorativi
22,00 € →
20,90 €
Cosa succederebbe se, ripercorrendo la nascita della scienza moderna e il contributo che ha dato al cambiamento dell'immagine dell'uomo, del…
|
|
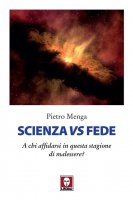
Libro
EAN 9788833537900 |
di Pietro Menga | -
Lindau Edizioni
(aprile 2022)
Normalmente disponibile in 15/16 giorni lavorativi
24,00 € →
22,80 €
La concezione del mondo e della vita tradizionalmente proposta dalla religione, che comprendeva il trascendente, tutta la conoscenza, le…
|
|
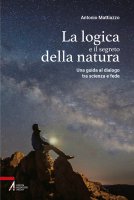
Libro
EAN 9788825054156 |
di Mons. Antonio Mattiazzo | -
Edizioni Messaggero
(aprile 2022)
Disponibilità immediata
15,00 € →
14,25 €
Sempre più il rapporto tra scienza e fede-filosofia suscita domande soprattutto nei giovani che si affacciano alla vita e cercano risposte…
|
|

Libro
EAN 9788860994882 |
di Luigi Secco | -
Gabrielli Editori
(marzo 2022)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
18,00 € →
17,10 €
Come il Maestro Nicolò Dallaporta ci ha insegnato, ci sono "due occhi" per guardare al Reale: la Scienza e la Trascendenza. Si tratta di due…
|
|
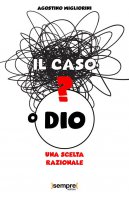
Libro
EAN 9788885589681 |
di Agostino Migliorini | -
Sempre Editore
(marzo 2022)
Normalmente disponibile in 20/21 giorni lavorativi
14,00 € →
13,30 €
Da dove ha origine l'universo e le leggi che lo regolano? Come è nato l'uomo e cosa lo distingue dagli animali? Perché avvengono…
|
|