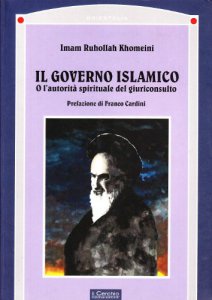Il governo islamico. O l'autorità spirituale del giuriconsulto
(Orientalia. Sez. Islam)EAN 9788884741301
Normalmente disponibile in 15/16 giorni lavorativi
CHI HA ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO HA SCELTO ANCHE
DETTAGLI DI «Il governo islamico. O l'autorità spirituale del giuriconsulto»
Tipo
Libro
Titolo
Il governo islamico. O l'autorità spirituale del giuriconsulto
Autore
Khomeynî Rûhollâh
Editore
Il Cerchio
EAN
9788884741301
Pagine
148
Data
2007
Collana
Orientalia. Sez. Islam
COMMENTI DEI LETTORI A «Il governo islamico. O l'autorità spirituale del giuriconsulto»
Non ci sono commenti per questo volume.
Lascia un tuo commento sui libri e gli altri prodotti in vendita e guadagna!
Recensioni di riviste specialistiche su «Il governo islamico. O l'autorità spirituale del giuriconsulto»
Recensione di Carlo Saccone della rivista Studia Patavina
Due testi che sono annoverabili tra le non molte «fonti primarie» reperibili in lingua italiana sullo sciismo iraniano di ieri e di oggi (l’editore Semar si segnala in particolare per avere in catalogo anche altri testi di autori sciiti contemporanei). Scritti da eminenti autorità spirituali, il loro pregio risiede dal punto di vista dello studioso del «fenomeno islam» nell’essere documenti importanti che provengono dall’interno dell’universo sciita e consentono, per esempio, di apprezzare come il mondo sciita si auto-rappresenta.
Il primo volume è una esposizione molto semplice e chiara del credo sciita, dai fondamenti dottrinari ai problemi di etica, con una sezione dedicata alla vita dei dodici imam venerati dallo sciismo duodecimano, l’ultimo dei quali è l’«imam atteso» o, altrimenti definito, l’«imam del tempo». Scomparso a Samarra nell’anno 873 non è creduto morto, bensì entrato in ghayba («occultamente», «assenza»); in altre parole, secondo la dottrina corrente, è ben vivo in corpore et spiritu e vigila sulla sua comunità. È detto «atteso» perché tornerà alla fine dei tempi ad instaurare un regno di giustizia sulla terra, risarcendo la comunità delle sofferenze patite nella storia: dal martirio di ‘Ali (assassinato da un fanatico kharijita nel 661) e l’uccisione del figlio Husayn (Hosseyn) a Kerbela (680) - i due primi imam riconosciuti dei dodici predetti - in avanti, fino alla fine dei tempi. Ciascuno di questi dodici imam è ritenuto una sorta di «manifestazione di Dio» in terra, la loro persona secondo la dottrina incorpora una particella di luce divina, sicché - per ricorrere a una terminologia teologica più familiare - in ciascuno di essi è distinguibile una doppia natura, umana e divina. Dottrine, queste dell’imam atteso e della doppia natura, condannate come eretiche dal mondo sunnita che in ogni tempo ha duramente perseguitato gli sciiti delle varie sette e sottosette. Ognuno può intendere -anche da questi pochi sommari cenni - come in queste dottrine riecheggi una potente «eco cristologica»: l’idea dell’«uomo-dio», della sua «morte che è una non-morte», del suo ritorno atteso ovvero di una seconda parusia, del regno finale della giustizia (un valore, questo, particolarmente sentito nel mondo sciita) denunciano - agli occhi dello studioso di storia delle religioni - evidenti matrici che pescano ad esempio nella apocalittica ebraico-cristiana e persino nel lascito della religione dell’antico Iran. Cristiani e musulmani sciiti apparentemente condividono molto: attendono la seconda parusia di una figura sacra, un «uomo divino», che è poi nella ritualità, nella dottrina e nel sentimento dei credenti, un ponte straordinario lanciato tra Dio e l’uomo e il punto di riferimento imprescindibile di tutta la vita e l’esperienza religiosa dei credenti.
Il volume dell’ayatollah Khomeyni, il protagonista della rivoluzione iraniana del 1979 e il fondatore dell’attuale Repubblica islamica d’Iran è autorevolmente prefato da Franco Cardini. Non si tratta di un saggio vero e proprio, bensì della raccolta delle lezioni che Khomeyni andò tenendo negli anni ’70 nelle scuole teologiche di Najaf, durante il suo esilio irakeno nella città santa degli sciiti (ospita fra l’altro il mausoleo di ‘Ali), sede con Qom in Iran della più prestigiosa howda o università religiosa dello sciismo duodecimano. Si tratta di trascrizioni fatte da studenti e discepoli, più tardi sistemate, raccolte e pubblicate con l’autorizzazione dell’augusto imam e col titolo originale di velayat-e faqih ossia «governo del giureconsulto».
In questi discorsi-lezioni l’imam sviluppava la sua discussa teoria politica che riconosceva alla gerarchia religiosa sciita un espresso diritto a esercitare un potere temporale al fine di edificare «il governo della legge divina sugli uomini». Il fine dichiarato è insomma l’instaurazione dello Stato Islamico conforme ai voleri di Dio, alla sua shari’a; il mezzo, ove non sia dato agire altrimenti -specie di fronte a un governo tirannico e antireligioso, come veniva giudicato quello dello shah - è la rivoluzione, la presa di potere con la forza e la gestione diretta dello Stato da parte del «partito di Dio». In sostanza, la gerarchia e il popolo sciita - secondo Khomeyni - dovevano farsi carico della promozione in terra dello «Stato di Dio»; in questo l’ultima parola nella gestione della cosa pubblica spetta ai religiosi e, in ultima istanza, alla massima autorità spirituale sciita che più tardi verrà individuata - anche a livello di dettato costituzionale - nella Guida della rivoluzione. In questo stato le leggi non le fa l’uomo o il popolo, le leggi le ha già date Dio, ma lasciamo la parola all’Autore: «La differenza fondamentale tra un governo islamico e la monarchia costituzionale o la repubblica risiede nel fatto che, mentre in questi regimi i rappresentanti del popolo si occupano di legiferare, nell’Islam il potere legislativo e la facoltà d legiferare sono prerogativa di Dio Altissimo: il sacro Legislatore è unico titolare del potere legislativo. Nessun altro ha il potere di legiferare, e nessuna norma che non sia la legge del Legislatore può trovare esecuzione. Per questa ragione nel governo islamico, al posto dell’‘assemblea legislativa’ (che è una delle tre suddivisioni del governo) si trova l’‘assemblea della pianificazione’ la quale redige i programmi dei diversi ministeri alla luce delle leggi dell’Islam e stabilisce le modalità di costituzione degli uffici pubblici in tutto il paese. I corpus delle leggi dell’Islam, rivelato con il Corano e la Sunna (=detti e sentenze di Maometto), è stato accettato dai musulmani i quali ne hanno fatto oggetto di obbedienza […] Il governo dell’Islam è il governo della legge. Nel suo governo la sovranità è prerogativa esclusiva di Dio, così come lo sono le leggi e i decreti»(pp. 41-42).
Il compito di condurre la cosa pubblica spetta di conseguenza a coloro che hanno due requisiti fondamentali: conoscenza della legge (‘elm) e rettitudine (‘adala) ossia ai giurisperiti (faqih), ai dottori della legge (‘ulama, etimologicamente «sapienti»). I «sapienti sono gli eredi dei profeti», ovvero «i depositari della fiducia dei profeti»; «i sapienti della comunità islamica sono come i profeti d’Israele»; «i re governano la gente, i sapienti governano i re», «i sapienti sono i reggitori/governatori del popolo»: così recitano alcuni celebri hadith o detti di Maometto che l’Autore - che sfoggia una perfetta padronanza delle fonti scritturali e una non comune dialettica - porta come argomento di autorità per corroborare la propria tesi del «governo del dottori» (velayat-e faqih). Di più: «è necessario che i dottori della legge istituiscano un governo legittimo [islamico], per poter applicare le leggi e mantenere ordine e limiti. Si tratta di un obbligo [religioso] individuale o collettivo, secondo che ve ne sia la possibilità o meno» (p. 49). E ancora: «Gli Imam, e i dottori della legge, dotati di rettitudine, hanno il compito di utilizzare il sistema e le istituzione dell’Islam per l’esecuzione delle leggi di Dio e per la realizzazione di un ordine giusto e al servizio del popolo» (p. 51).
Queste idee, che prospettavano per la prima volta in modo organico un «attivismo rivoluzionario» come dovere religioso, rompevano con la lunga tradizione quietista dell’Islam sciita duodecimano e, per ciò stesso, durarono parecchio a prendere piede e affermarsi nella stessa gerarchia religiosa. Nella tradizione sciita era corrente l’idea che i religiosi avessero il dovere di guidare e «consigliare» il Principe, mentre la conquista o la gestione diretta del potere non era mai stata vista né proposta come un obiettivo o un dovere religioso. Khomeyni su questo punto fu duramente contestato sia in Irak, soprattutto dal grande ayatollah al-Khu’i, sia in Iran dove però, dopo la Rivoluzione e la presa del potere nel 1979, i religiosi dissenzienti furono gradualmente ma inesorabilmente emarginati (compreso l’ayatollah Montazeri, in un primo tempo indicato dallo stesso Khomeyni come suo successore).
Due testi dunque un po’ particolari, non di studio o pura ricerca accademica bensì orientati alla prassi, scritti in modo relativamente semplice e piano, rivolti, il primo, al credente comune, il secondo, allo studente e al militante. Il primo è in sostanza un catechismo dello sciismo duodecimano, utile vademecum per i credenti sciiti, e utilissimo anche per lo studioso perché fornisce un’idea piuttosto precisa di che cosa un credente sciita mediamente istruito professa e crede, o deve credere; il secondo è un testo militante, che ha lo scopo di chiarire presupposti e scopi dell’azione rivoluzionaria volta a instaurare lo stato teocratico, lo stato di Dio gestito dai dottori della legge.
Negli ultimi tempi del regime dello shah, nella stampa europea, si era diffusa una certa spontanea simpatia per la figura ieratica e carismatica dell’ayatollah Khomeyni che, con la sola forza morale dei suoi discorsi, raccolti in esilio e diffusi dappertutto in Iran attraverso le registrazioni, aveva animato le manifestazioni di protesta di massa che portarono poi alla caduta del regime. Una certa forte simpatia suscitò Khomeyni anche negli ambienti della sinistra europea per gli accenti terzomondisti e anti-imperialisti della sua predicazione. Proprio nel volume che qui presentiamo, dopo avere citato un passo dai sermoni dell’imam Husayn (Hosseyn) in cui fra l’altro si legge che «Dio li biasimò (i rabbini dì Israele) e rimproverò per questo: perché personalmente vedevano gli oppressori commettere i loro atti illeciti e corrotti e non facevano niente per fermarli, desiderando continuare a guadagnare quello che essi davano loro e temendo la loro punizione», Khomeyni così commenta: «è evidente che rimproveri di tal fatta non sono riferiti esclusivamente ai dotti (=sacerdoti) ebrei né a quelli cristiani, ma sono rivolti ai sapienti (=ulema) della società islamica, anzi ai sapenti di tutte le religioni indistintamente. Pertanto anche gli ulema della società islamica, là dove rimangano inerti testimoni delle azioni politiche degli oppressori, sono inevitabile oggetto del biasimo divino» (p. 98). Oppressori che, più avanti, sono individuati con le «compagnie straniere» e le multinazionali che saccheggiano le risorse dl Terzo Mondo e le grandi potenze mai mondate dal vizio del colonialismo e i regimi fantoccio dei paesi sottosviluppati. Khomeyni, inaspettatamente, spezza anche una lancia a favore del Cristianesimo, in sostanza assolvendolo dall’accusa di «complicità con l’imperialismo» dicendo che «lo scopo dei colonialisti non consisteva nell’allontanare la gente dall’Islam ufficiale affinché il Cristianesimo potesse pendere piede. No, costoro non avevano a cuore le sorti del Cristianesimo come non si curavano di quello dell’Islam. Al contrario, in questo periodo… avevano imparato che esso costituiva un ostacolo al conseguimento dei loro interessi materiali» (p. 13).
Ma, successivamente, l’atteggiamento iniziale di simpatia dell’intellighenzia europea si spense: man mano che la legge islamica veniva imposta nel paese, l’opposizione emarginata, la stampa censurata, le libertà private compresse e delegittimate, la pena di morte applicata agli adulteri e agli omosessuali, si cominciò a parlare in Europa e in America di «ritorno al medio evo», di «oscurantismo» islamico ecc. L’era della presidenza Khatami, a cavallo del cambio di millennio, segnò un nuovo corso: riaprì nuovi spazi di libertà e democrazia, nuovi giornali, nuovi movimenti intellettuali, libere associazioni ecc. trovarono spazio, dando vita in Iran a un dibattito politico e ideale vivacissimo a malapena contenuto dalla censura, un dibattito che continua ancora oggi, nonostante i periodici giri di vite.
Franco Cardini, nella sua acuta prefazione, mette in guardia dal giudicare frettolosamente il fenomeno e, giustamente, coglie gli aspetti di «modernità» di questa rivoluzione che si nutre, specie agli inizi, di un vocabolario para-marxista (l’avanguardia rivoluzionaria, l’alienazione, lo sfruttamento, l’emancipazione degli oppressi, la lotta anti-imperialista) e, pur tra eccessi e abusi in materia di diritti civili e errori catastrofici in politica estera, cerca sul filo del rasoio di coniugare religione e democrazia, Islam e elezioni a suffragio universale, autorità della Guida e libertà di stampa, velo e emancipazione femminile (in Iran, a differenza ad esempio dell’Arabia Saudita, le donne guidano, lavorano e hanno accesso a tutte le professioni, rappresentano persino la maggioranza della popolazione universitaria e partecipano attivamente alla vita politica e amministrativa).
Ma emerge in questo grande «laboratorio Iran» anche un altro aspetto, che guarda non al Moderno bensì al passato, un passato mitico, quello della prima comunità musulmana fondata da Maometto a Medina, governata dalla sola «legge di Dio», idealizzata e posta a modello insuperabile di organizzazione della comunità umana sulla terra, idea che com’è noto si ritrova in tutto il variegato arco dell’Islam radicale e che indubbiamente è al centro del programma politico originario dell’ayatollah Khomeyni. E c’è ancora dell’altro, che non andrebbe sottovalutato: mi riferisco al lato utopico che, mi sembra, lega profondamente il «laboratorio Iran» a certe correnti di pensiero politico-utopistico maturate nella stessa tradizione filosofica del mondo islamico. Si pensi alla madina fadila, la «città perfetta» dell’omonimo trattato utopistico del filosofo arabo ellenizzante al-Farabi (X sec., leggibile anche in italiano: La città virtuosa, a cura di M. Campanini, Rizzoli, Milano 1996), che riecheggia ben noti modelli classici: una città perfetta perché guidata dai sapienti, dai filosofi che programmaticamente mettono d’accordo la ragione con la legge religiosa, la filosofia con la rivelazione (idea che farà strada fino al «Trattato decisivo sull’accordo tra la religione e la filosofia» di Averroè). Ebbene, lo stato diretto o supervisionato dai dottori della legge, ossia dai «sapienti» (tale, abbiamo visto, è il senso etimologico di ‘ulama, italianizzato in ulema), ci sembra riecheggiare ampiamente, nel bene e nel male, questa antichissima «temeraria» utopia che - come si vede - appartiene al patrimonio genetico del mondo musulmano non meno che a quello del mondo cristiano. Qualcosa (ma ce ne sono tante altre…) che ci fa comprendere come il mondo musulmano non sia affatto «altro» dall’Occidente, ma una sua parte, una sua componente che dopo una lunga eclisse è tornata alla ribalta della storia.
Tratto dalla rivista "Studia Patavina" 2007, nr. 3
(http://www.fttr.glauco.it/pls/fttr/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=271)
Il primo volume è una esposizione molto semplice e chiara del credo sciita, dai fondamenti dottrinari ai problemi di etica, con una sezione dedicata alla vita dei dodici imam venerati dallo sciismo duodecimano, l’ultimo dei quali è l’«imam atteso» o, altrimenti definito, l’«imam del tempo». Scomparso a Samarra nell’anno 873 non è creduto morto, bensì entrato in ghayba («occultamente», «assenza»); in altre parole, secondo la dottrina corrente, è ben vivo in corpore et spiritu e vigila sulla sua comunità. È detto «atteso» perché tornerà alla fine dei tempi ad instaurare un regno di giustizia sulla terra, risarcendo la comunità delle sofferenze patite nella storia: dal martirio di ‘Ali (assassinato da un fanatico kharijita nel 661) e l’uccisione del figlio Husayn (Hosseyn) a Kerbela (680) - i due primi imam riconosciuti dei dodici predetti - in avanti, fino alla fine dei tempi. Ciascuno di questi dodici imam è ritenuto una sorta di «manifestazione di Dio» in terra, la loro persona secondo la dottrina incorpora una particella di luce divina, sicché - per ricorrere a una terminologia teologica più familiare - in ciascuno di essi è distinguibile una doppia natura, umana e divina. Dottrine, queste dell’imam atteso e della doppia natura, condannate come eretiche dal mondo sunnita che in ogni tempo ha duramente perseguitato gli sciiti delle varie sette e sottosette. Ognuno può intendere -anche da questi pochi sommari cenni - come in queste dottrine riecheggi una potente «eco cristologica»: l’idea dell’«uomo-dio», della sua «morte che è una non-morte», del suo ritorno atteso ovvero di una seconda parusia, del regno finale della giustizia (un valore, questo, particolarmente sentito nel mondo sciita) denunciano - agli occhi dello studioso di storia delle religioni - evidenti matrici che pescano ad esempio nella apocalittica ebraico-cristiana e persino nel lascito della religione dell’antico Iran. Cristiani e musulmani sciiti apparentemente condividono molto: attendono la seconda parusia di una figura sacra, un «uomo divino», che è poi nella ritualità, nella dottrina e nel sentimento dei credenti, un ponte straordinario lanciato tra Dio e l’uomo e il punto di riferimento imprescindibile di tutta la vita e l’esperienza religiosa dei credenti.
Il volume dell’ayatollah Khomeyni, il protagonista della rivoluzione iraniana del 1979 e il fondatore dell’attuale Repubblica islamica d’Iran è autorevolmente prefato da Franco Cardini. Non si tratta di un saggio vero e proprio, bensì della raccolta delle lezioni che Khomeyni andò tenendo negli anni ’70 nelle scuole teologiche di Najaf, durante il suo esilio irakeno nella città santa degli sciiti (ospita fra l’altro il mausoleo di ‘Ali), sede con Qom in Iran della più prestigiosa howda o università religiosa dello sciismo duodecimano. Si tratta di trascrizioni fatte da studenti e discepoli, più tardi sistemate, raccolte e pubblicate con l’autorizzazione dell’augusto imam e col titolo originale di velayat-e faqih ossia «governo del giureconsulto».
In questi discorsi-lezioni l’imam sviluppava la sua discussa teoria politica che riconosceva alla gerarchia religiosa sciita un espresso diritto a esercitare un potere temporale al fine di edificare «il governo della legge divina sugli uomini». Il fine dichiarato è insomma l’instaurazione dello Stato Islamico conforme ai voleri di Dio, alla sua shari’a; il mezzo, ove non sia dato agire altrimenti -specie di fronte a un governo tirannico e antireligioso, come veniva giudicato quello dello shah - è la rivoluzione, la presa di potere con la forza e la gestione diretta dello Stato da parte del «partito di Dio». In sostanza, la gerarchia e il popolo sciita - secondo Khomeyni - dovevano farsi carico della promozione in terra dello «Stato di Dio»; in questo l’ultima parola nella gestione della cosa pubblica spetta ai religiosi e, in ultima istanza, alla massima autorità spirituale sciita che più tardi verrà individuata - anche a livello di dettato costituzionale - nella Guida della rivoluzione. In questo stato le leggi non le fa l’uomo o il popolo, le leggi le ha già date Dio, ma lasciamo la parola all’Autore: «La differenza fondamentale tra un governo islamico e la monarchia costituzionale o la repubblica risiede nel fatto che, mentre in questi regimi i rappresentanti del popolo si occupano di legiferare, nell’Islam il potere legislativo e la facoltà d legiferare sono prerogativa di Dio Altissimo: il sacro Legislatore è unico titolare del potere legislativo. Nessun altro ha il potere di legiferare, e nessuna norma che non sia la legge del Legislatore può trovare esecuzione. Per questa ragione nel governo islamico, al posto dell’‘assemblea legislativa’ (che è una delle tre suddivisioni del governo) si trova l’‘assemblea della pianificazione’ la quale redige i programmi dei diversi ministeri alla luce delle leggi dell’Islam e stabilisce le modalità di costituzione degli uffici pubblici in tutto il paese. I corpus delle leggi dell’Islam, rivelato con il Corano e la Sunna (=detti e sentenze di Maometto), è stato accettato dai musulmani i quali ne hanno fatto oggetto di obbedienza […] Il governo dell’Islam è il governo della legge. Nel suo governo la sovranità è prerogativa esclusiva di Dio, così come lo sono le leggi e i decreti»(pp. 41-42).
Il compito di condurre la cosa pubblica spetta di conseguenza a coloro che hanno due requisiti fondamentali: conoscenza della legge (‘elm) e rettitudine (‘adala) ossia ai giurisperiti (faqih), ai dottori della legge (‘ulama, etimologicamente «sapienti»). I «sapienti sono gli eredi dei profeti», ovvero «i depositari della fiducia dei profeti»; «i sapienti della comunità islamica sono come i profeti d’Israele»; «i re governano la gente, i sapienti governano i re», «i sapienti sono i reggitori/governatori del popolo»: così recitano alcuni celebri hadith o detti di Maometto che l’Autore - che sfoggia una perfetta padronanza delle fonti scritturali e una non comune dialettica - porta come argomento di autorità per corroborare la propria tesi del «governo del dottori» (velayat-e faqih). Di più: «è necessario che i dottori della legge istituiscano un governo legittimo [islamico], per poter applicare le leggi e mantenere ordine e limiti. Si tratta di un obbligo [religioso] individuale o collettivo, secondo che ve ne sia la possibilità o meno» (p. 49). E ancora: «Gli Imam, e i dottori della legge, dotati di rettitudine, hanno il compito di utilizzare il sistema e le istituzione dell’Islam per l’esecuzione delle leggi di Dio e per la realizzazione di un ordine giusto e al servizio del popolo» (p. 51).
Queste idee, che prospettavano per la prima volta in modo organico un «attivismo rivoluzionario» come dovere religioso, rompevano con la lunga tradizione quietista dell’Islam sciita duodecimano e, per ciò stesso, durarono parecchio a prendere piede e affermarsi nella stessa gerarchia religiosa. Nella tradizione sciita era corrente l’idea che i religiosi avessero il dovere di guidare e «consigliare» il Principe, mentre la conquista o la gestione diretta del potere non era mai stata vista né proposta come un obiettivo o un dovere religioso. Khomeyni su questo punto fu duramente contestato sia in Irak, soprattutto dal grande ayatollah al-Khu’i, sia in Iran dove però, dopo la Rivoluzione e la presa del potere nel 1979, i religiosi dissenzienti furono gradualmente ma inesorabilmente emarginati (compreso l’ayatollah Montazeri, in un primo tempo indicato dallo stesso Khomeyni come suo successore).
Due testi dunque un po’ particolari, non di studio o pura ricerca accademica bensì orientati alla prassi, scritti in modo relativamente semplice e piano, rivolti, il primo, al credente comune, il secondo, allo studente e al militante. Il primo è in sostanza un catechismo dello sciismo duodecimano, utile vademecum per i credenti sciiti, e utilissimo anche per lo studioso perché fornisce un’idea piuttosto precisa di che cosa un credente sciita mediamente istruito professa e crede, o deve credere; il secondo è un testo militante, che ha lo scopo di chiarire presupposti e scopi dell’azione rivoluzionaria volta a instaurare lo stato teocratico, lo stato di Dio gestito dai dottori della legge.
Negli ultimi tempi del regime dello shah, nella stampa europea, si era diffusa una certa spontanea simpatia per la figura ieratica e carismatica dell’ayatollah Khomeyni che, con la sola forza morale dei suoi discorsi, raccolti in esilio e diffusi dappertutto in Iran attraverso le registrazioni, aveva animato le manifestazioni di protesta di massa che portarono poi alla caduta del regime. Una certa forte simpatia suscitò Khomeyni anche negli ambienti della sinistra europea per gli accenti terzomondisti e anti-imperialisti della sua predicazione. Proprio nel volume che qui presentiamo, dopo avere citato un passo dai sermoni dell’imam Husayn (Hosseyn) in cui fra l’altro si legge che «Dio li biasimò (i rabbini dì Israele) e rimproverò per questo: perché personalmente vedevano gli oppressori commettere i loro atti illeciti e corrotti e non facevano niente per fermarli, desiderando continuare a guadagnare quello che essi davano loro e temendo la loro punizione», Khomeyni così commenta: «è evidente che rimproveri di tal fatta non sono riferiti esclusivamente ai dotti (=sacerdoti) ebrei né a quelli cristiani, ma sono rivolti ai sapienti (=ulema) della società islamica, anzi ai sapenti di tutte le religioni indistintamente. Pertanto anche gli ulema della società islamica, là dove rimangano inerti testimoni delle azioni politiche degli oppressori, sono inevitabile oggetto del biasimo divino» (p. 98). Oppressori che, più avanti, sono individuati con le «compagnie straniere» e le multinazionali che saccheggiano le risorse dl Terzo Mondo e le grandi potenze mai mondate dal vizio del colonialismo e i regimi fantoccio dei paesi sottosviluppati. Khomeyni, inaspettatamente, spezza anche una lancia a favore del Cristianesimo, in sostanza assolvendolo dall’accusa di «complicità con l’imperialismo» dicendo che «lo scopo dei colonialisti non consisteva nell’allontanare la gente dall’Islam ufficiale affinché il Cristianesimo potesse pendere piede. No, costoro non avevano a cuore le sorti del Cristianesimo come non si curavano di quello dell’Islam. Al contrario, in questo periodo… avevano imparato che esso costituiva un ostacolo al conseguimento dei loro interessi materiali» (p. 13).
Ma, successivamente, l’atteggiamento iniziale di simpatia dell’intellighenzia europea si spense: man mano che la legge islamica veniva imposta nel paese, l’opposizione emarginata, la stampa censurata, le libertà private compresse e delegittimate, la pena di morte applicata agli adulteri e agli omosessuali, si cominciò a parlare in Europa e in America di «ritorno al medio evo», di «oscurantismo» islamico ecc. L’era della presidenza Khatami, a cavallo del cambio di millennio, segnò un nuovo corso: riaprì nuovi spazi di libertà e democrazia, nuovi giornali, nuovi movimenti intellettuali, libere associazioni ecc. trovarono spazio, dando vita in Iran a un dibattito politico e ideale vivacissimo a malapena contenuto dalla censura, un dibattito che continua ancora oggi, nonostante i periodici giri di vite.
Franco Cardini, nella sua acuta prefazione, mette in guardia dal giudicare frettolosamente il fenomeno e, giustamente, coglie gli aspetti di «modernità» di questa rivoluzione che si nutre, specie agli inizi, di un vocabolario para-marxista (l’avanguardia rivoluzionaria, l’alienazione, lo sfruttamento, l’emancipazione degli oppressi, la lotta anti-imperialista) e, pur tra eccessi e abusi in materia di diritti civili e errori catastrofici in politica estera, cerca sul filo del rasoio di coniugare religione e democrazia, Islam e elezioni a suffragio universale, autorità della Guida e libertà di stampa, velo e emancipazione femminile (in Iran, a differenza ad esempio dell’Arabia Saudita, le donne guidano, lavorano e hanno accesso a tutte le professioni, rappresentano persino la maggioranza della popolazione universitaria e partecipano attivamente alla vita politica e amministrativa).
Ma emerge in questo grande «laboratorio Iran» anche un altro aspetto, che guarda non al Moderno bensì al passato, un passato mitico, quello della prima comunità musulmana fondata da Maometto a Medina, governata dalla sola «legge di Dio», idealizzata e posta a modello insuperabile di organizzazione della comunità umana sulla terra, idea che com’è noto si ritrova in tutto il variegato arco dell’Islam radicale e che indubbiamente è al centro del programma politico originario dell’ayatollah Khomeyni. E c’è ancora dell’altro, che non andrebbe sottovalutato: mi riferisco al lato utopico che, mi sembra, lega profondamente il «laboratorio Iran» a certe correnti di pensiero politico-utopistico maturate nella stessa tradizione filosofica del mondo islamico. Si pensi alla madina fadila, la «città perfetta» dell’omonimo trattato utopistico del filosofo arabo ellenizzante al-Farabi (X sec., leggibile anche in italiano: La città virtuosa, a cura di M. Campanini, Rizzoli, Milano 1996), che riecheggia ben noti modelli classici: una città perfetta perché guidata dai sapienti, dai filosofi che programmaticamente mettono d’accordo la ragione con la legge religiosa, la filosofia con la rivelazione (idea che farà strada fino al «Trattato decisivo sull’accordo tra la religione e la filosofia» di Averroè). Ebbene, lo stato diretto o supervisionato dai dottori della legge, ossia dai «sapienti» (tale, abbiamo visto, è il senso etimologico di ‘ulama, italianizzato in ulema), ci sembra riecheggiare ampiamente, nel bene e nel male, questa antichissima «temeraria» utopia che - come si vede - appartiene al patrimonio genetico del mondo musulmano non meno che a quello del mondo cristiano. Qualcosa (ma ce ne sono tante altre…) che ci fa comprendere come il mondo musulmano non sia affatto «altro» dall’Occidente, ma una sua parte, una sua componente che dopo una lunga eclisse è tornata alla ribalta della storia.
Tratto dalla rivista "Studia Patavina" 2007, nr. 3
(http://www.fttr.glauco.it/pls/fttr/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=271)
TAGS DI «Il governo islamico. O l'autorità spirituale del giuriconsulto»