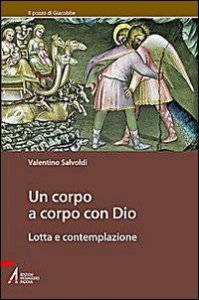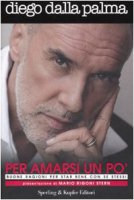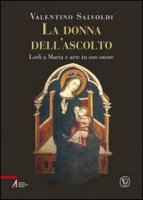Riflessioni sulla difficoltà della preghiera che non sempre è lode e adorazione, a volte è lotta, disperazione, difficile accettazione che però porta con sé la dolce sublimazione della Sua volontà.
INTRODUZIONE
Come una cerva assetata allo wadi
Matera. In preparazione alla Pasqua, i ragazzi dei licei cittadini sono invitati a una «tre giorni» di discussione sul tema: «Tu vivi solo il tempo dell'amore». Da ottobre stavano leggendo i miei libri e c'era aspettativa per «l'incontro con l'autore». Erano più di cinquecento e seguivano attentamente le relazioni. Al metodo narrativo, univo una serie di provocazioni, per dare stimoli ai futuri gruppi di studio. Provocazioni e sfide, quali: «Se non cerchi Dio, difficilmente riuscirai ad amare in modo autentico. Se "Dio è amore" — come afferma l'apostolo Giovanni — anche l'amore è Dio. E il Signore non è geloso dei nostri amori, anzi ne è il garante».
Da questa premessa ne conseguiva la necessità di cercare Dio con il cuore, prima che con l'intelligenza, di fissare lo sguardo su Cristo, esperto in umanità, di fare della preghiera il nostro respiro, mettendo l'Amore (lo Spirito Santo) tra noi e quanti amiamo.
Il primo giorno la risposta della maggior parte degli studenti era entusiasmante. Il secondo giorno notai una tensione in alcuni, che, nell'intervallo, disputavano animatamente. Chiesi il motivo. Una ragazza mi domandò di esporre il suo pensiero davanti all'assemblea a nome di chi si riteneva ateo. Precise le «accuse»: «Lei parla di Dio come se fosse innamorato di Lui e questo disturba noi che non crediamo nel trascendente. Lei che è stato anche professore di filosofia, parli da filosofo e non da teologo. Vogliamo discorsi concreti, prove e dimostrazioni. E sappia che si può essere atei ed esperti nell'amore come si può essere cattolici praticanti e non saper amare, non saper vivere. Infine, perché dovremmo pregare?».
Benché cercassi di nasconderla, si poteva leggere sul mio volto l'amarezza che provavo per quelle parole: «Cari ragazzi, siccome siete perspicaci, non fate un insulto alla vostra intelligenza: non dite di essere atei, ma "agnostici", vale a dire che considerate inconoscibile tutto ciò che non è sottoposto ai metodi della scienza positiva e che non prendete posizione su un problema più grande di voi».
Il gruppetto degli «atei» reagì immediatamente, cercando di dimostrare che il male del mondo era la prova più evidente della non esistenza del mio Dio. Altro che «Dio-amore». Se esistesse sarebbe da giudicare un boia, un sadico, un criminale!
Li guardai ancora più amareggiato e aggiunsi: «Ragazzi, mi rincresce che la società vi abbia rubato l'intelligenza, il cuore, il corpo, la fede, la nostalgia di pregare e la gioia di cercare Dio». E spiegai dettagliatamente il perché di questo furto e le conseguenze nefaste per chi non ha una fede e non vive con un cuore che ascolta e indaga la verità.
La portavoce degli «atei» — rafforzata dalla crescente stima dei suoi sostenitori — sbottò con questa affermazione: «Noi non l'accettiamo per nulla». Al che, dopo qualche secondo di silenzio, si alzò un ragazzo, diciassettenne, con una selva di capelli, con orecchini e piercing, vestito da «sfattone» e con una grande Tau appesa al collo, lentamente si mosse verso quella ragazza e, puntato il dito, si limitò a dire: «Tu parla per te stessa» e, dignitosamente tornò al suo posto, lungamente acclamato da uno scroscio di applausi.
Per me non fu una rivincita. Guardando i «giovani atei», mi scesero alcune lacrime. Una ragazza mi chiese il permesso di baciarmi. Altre studentesse e studenti, nell'intervallo, fecero altrettanto.
Ripreso l'incontro, espressi l'idea che sarebbe stato più utile che io mi ritirassi a pregare per loro, anziché continuare a discutere. Espressi il desiderio di ritirarmi ai «Sassi», il posto più bello della città, sede di grotte che, nel passato, erano state popolate anche da monaci ed eremiti: sarebbe stato più facile percepire Dio là dove altri avevano pregato, sognato, sperato.
Qualcuno obiettò: «Dio, se c'è, non scappa. Puoi sempre trovarlo. Ora resta con noi e parlaci di lui». Raccontai allora un incontro vissuto dodici anni prima in Etiopia, per mostrare il diverso atteggiamento dallo studente europeo in confronto a quello africano. Quest'ultimo chiede: «Insegnaci a pregare», mentre il ragazzo occidentale si pone la domanda: «Perché debbo pregare?».
Gli studenti etiopi, eterogenei dal punto di vista culturale e religioso, volevano che io parlassi non come un «professore» di Dio, ma come un testimone. Volevano conoscere la mia esperienza di fede e quanto il Signore potesse riempire la mia vita:
«Come preghi?».
«Fino a che punto la preghiera è significativa per te e cambia la tua esistenza?». «In che modo la tua preghiera diventa vita?». «Come fondi armonicamente preghiera e azione?».
«In che modo Cristo è presente nella tua preghiera?».
«Perché Cristo può suscitare l'interesse di persone appartenenti a culture diverse da quella cristiana e cattolica?».
Quei ragazzi etiopi non si sentivano a disagio nel formulare questioni strettamente personali:
«Hai avuto momenti di crisi?».
«Ti è sempre facile "toccare Dio"?».
«Come affronti il silenzio di Dio?».
«Non ti è costato caro mettere in pratica i comandamenti di Dio?».
«In particolare, come fai a parlare tanto d'amore e a vivere poi da celibe?».
Avevo trascorso cinque giorni con i ragazzi etiopi, cercando di rendere conto della speranza che c'è in me. Speranza in un Dio che per me è estasi e tormento. Speranza alimentata continuamente dalla preghiera. Preghiera personale e collettiva.
Dopo aver raccontato questa esperienza agli studenti di Matera, là, ai Sassi, dopo aver celebrato l'eucaristia al tramonto del sole, che rendeva affascinanti gli ulivi, nel cielo fattosi rosa, alcuni di loro mi hanno rivolto la richiesta degli apostoli a Gesù: «Maestro, insegnaci a pregare».
A loro rispondo con questo libro, sintesi di quanto avevo condiviso con gli studenti etiopi, assetati di Dio, come cerva che allo wadi, nel deserto, non trova l'acqua e urla al cielo la sua disperazione. Immagine usata dal Salmista per adombrare l'idea che la preghiera è contemporaneamente lotta e contemplazione.
ESTRATTO DAL PRIMO CAPITOLO
DI NOTTE AL GUADO DEL FIUME
Lotta con Dio
Durante quella notte, Giacobbe si alzò, prese le due sue mogli, le due sue serve, i suoi undici figlioli e attraversò il guado dello Iabbok. Li prese e fece loro attraversare il torrente e fece passare anche tutto il suo avere. Giacobbe rimase solo, e un uomo lottò contro di lui fino allo spuntare dell'aurora.
Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo percosse nel cavo del femore; e il cavo del femore di Giacobbe si lussò, mentre egli si abbracciava con lui. Disse colui: «Lasciami andare, che spunta l'aurora». Rispose: «Non ti lascerò partire se non mi avrai benedetto». Gli domandò colui: «Qual è il tuo nome?». Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non più Giacobbe sarà il tuo nome, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto». Giacobbe allora gli chiese: «Dimmi il tuo nome, ti prego!». Gli rispose: «Perché chiedi il mio nome?». E lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penule, «perché — disse — ho visto Dio faccia a faccia eppure la mia vita è rimasta salva». Il sole spuntò quando egli ebbe passato Penule e Giacobbe zoppicava all'anca (Gn 32,23-32).