La storia degli ebrei
-In cerca delle parole. Dalle origini al 1492
(Le scie)Simon Schama
EAN 9788804643654
Nel giugno del 1242, a Parigi, davanti a una folla urlante e a frati raccolti in preghiera, migliaia di pergamene inchiostrate recanti lettere ebraiche arsero sulle pire scoppiettanti diffondendo lungo le rive della Senna un dolciastro fetore animale. Sui roghi, innalzati per volontà di re Luigi IX il Santo, avvampavano le copie del Talmud.
La parola di Dio, proprio come i corpi viventi che cadevano tra le braccia dell'Inquisizione, bruciava nelle fiamme. Iniziava così, per il Popolo del Libro, un'altra pagina della sua storia millenaria di sofferenze e persecuzioni. Eppure, come ci ricorda Simon Schama, docente alla Columbia University, questa storia non si consumò solo nel lutto e nelle fughe improvvise, nelle costanti minacce di annientamento e nell'oppressione. Quella del popolo ebraico è soprattutto una storia di resistenza, di creatività, di gioia. Una continua, e a tratti disperata, affermazione della vita sulle avversità più spaventose. In queste pagine si dipana quindi una straordinaria epopea, fatta di gente comune e di poeti, di autori biblici e medici illustri, di miniaturisti e mercanti, di cartografi e filosofi. Un caleidoscopio di microstorie in cui si accendono candele, si intonano canti, si affrontano viaggi perigliosi in terre incognite alla ricerca di spezie e pietre preziose, si studiano, si custodiscono e si perpetuano le parole del Libro. Un racconto che abbraccia millenni e continenti...
PREFAZIONE
Non posso dire di non essere stato avvertito. «Figlio mio» ammonisce con gelida saggezza il predicatore dell'Ecclesiaste «scrivere molti libri e studiare troppo è una fatica per il corpo.» Chiunque si avventuri nella storia ebraica dev'essere consapevole, a rischio di scoraggiarsi, delle immense catene montuose di studi in più volumi che torreggiano alle sue spalle. Quarant'anni fa, tuttavia, accettai di portare a termine uno di questi studi, una storia degli ebrei rimasta incompiuta alla morte dell'autore, Cecil Roth, che aveva dedicato l'intera vita all'argomento. A quel tempo stavo lavorando a un libro sui Rothschild e la Palestina. Insieme a un amico e collega all'Università di Cambridge, Nicholas de Lange, studioso di filosofia ebraica della tarda antichità e traduttore di Amos Oz, mi ero formato a spese degli studenti in storia post-biblica grazie a un seminario informale che tenevamo nelle mie stanze al Christ's College. Per un paio d'ore, dopo cena, mentre schiacciavamo noci e scherzavamo, bevendo bicchieri di vino e coppe traboccanti di parole ebraiche, accoglievamo nella nostra piccola compagnia saggi, falsi messia, poeti e agitatori.
Ma Nicholas e io avevamo organizzato quegli incontri per una ragione seria. Rabbini a parte, gli studenti di storia o letteratura non avevano nessuno, ci sembrava, con cui incontrarsi per parlare di cultura ebraica, segno di quanto essa fosse divenuta estranea all'università. Quando mi giunse l'invito a portare a termine il volume di Roth, inoltre, ulteriori urgenti motivi spingevano a voler creare un collegamento fra la storia degli ebrei e quella diti tti. Era il 1973, e si era appena combattuta la guerra arabo-israeliana dello Yon Kippur. Nonostante il successo militare di Israele, l'umore era cupo: il conflitto era stato molto duro, specie durante l'audace avanzata egiziana oltre il canale di Suez e nel Sinai. Le sabbie erano diventate mobili;qualcosa che era sembrato sicuro non lo era più. Gli anni che seguirono videro la storiografia ebraica, a entrambe le estremità della sua plurimillenaria cronologia, autocriticare ferocemente il trionfalismo. L'archeologia biblica prese una piega radicalmente scettica. Su quanto era esattamente avvenuto fra ebrei e palestinesi nel 1948 iniziarono a circolare verità dolorose. La prolungata occupazione e, poi, la sfida della prima intifada divennero realtà ineludibili. Parlare con non ebrei di storia ebraica senza impantanarsi nella storia del conflitto israelo-palestinese era ormai impossibile. E sopra ogni altra cosa, comprensibilmente, continuava ad aleggiare la tragica nuvola di fumo dei forni crematori. Le dimensioni senza pari di quella catastrofe sembravano chiedere silenzio di fronte alla sua enormità, sia agli ebrei sia ai gentili.
Ma, quale ne sia il costo, spezzare il silenzio non è un'opzione per uno storico. Pensavo che scrivendo una storia postmedievale rivolta al grande pubblico, che desse tutto il suo peso alle esperienze condivise, non sempre e soltanto a persecuzioni e massacri, avrei potuto fungere da interlocutore, convincere i lettori (e i responsabili dei programmi di studio in storia) che nessuna storia, su qualunque regione del mondo o epoca si focalizzasse, poteva dirsi completa senza una storia ebraica, e che in quest'ultima c'era molto di più che pogrom e rabbini, una cronaca popolata da antiche vittime e moderni conquistatori.
Era questa l'inclinazione in cui ero cresciuto. Mio padre era ossessionato in pari misura dalla storia ebraica e da quella britannica, e gli sembrava che andassero a braccetto.
Oppure: chi aveva azzeccato i suoi ebrei? Walter Scott o George Eliot, il Dickens caricaturale di Oliver Twist o il Dickens sentimentale del Nostro comune amico? Ormeggiavamo sotto i salici alle prese con il dolore di Shylock. È dai miei genitori, inoltre, che ho ereditato l'idea che l'Antico Testamento sia la prima storia scritta in assoluto; che, nonostante tutte le sue licenze poetiche, a cominciare dai miracoli, sia lo snodarsi di schiavitù e liberazioni, hybris regali e ribellioni filiali, assedi e distruzioni, imposizioni e violazioni della legge: il modello su cui si sarebbe foggiata ogni altra storia successiva. Se mio padre ne avesse scritta una, si sarebbe chiamata «Da Mosè alla Magna Charta». Ma non la scrisse.
E nemmeno io, non nel 1973. Ci provai, portando avanti la narrazione di Cecil Roth, ma, quale che ne sia il motivo, l'innesto non fece presa. Dopodiché passai quarant'anni a errare, non esattamente nel deserto, ma in regioni lontane dal mio retroterra ebraico: Olanda e South Carolina, Skara Brae e la Parigi giacobina. Ma, per tutto quel tempo, i lineamenti della storia che avrei potuto raccontare rimasero sempre presenti, sia pur flebilmente, nei miei pensieri e ricordi, come parenti che mi tiravano delicatamente ma con insistenza per la manica a matrimoni o funerali di famiglia (cosa che a volte avvenne). Mai sottovalutare il potere di una zia ebrea, né tanto meno il muto, paziente rimprovero di una madre.
Così, nel 2009, quando Adam Kemp della BBC organizzò un incontro per parlarmi di un'idea per un nuovo documentario televisivo a puntate «che ti affascinerà o detesterai», sapevo in qualche modo, ancora prima che gli uscisse una parola di bocca, che cosa mi aspettava. Ci fu, lo ammetto, un fugace momento in cui mi sentii Giona.
Questa volta la storia porta dietro di sé il potere persuasivo della televisione, e attraverso i due media, scrittura e filmati, organicamente interconnessi ma non identici, speravo di costruire proprio quel ponte fra pubblico ebreo e pubblico non ebreo che sembrava in qualche modo avermi eluso quarant'anni prima.
Nonostante le sfide incommensurabili che ha posto (tre millenni di storia in cinque ore di televisione e due libri), si è trattato di un grande e appassionante lavoro, e tale lo sento tuttora. Per quanto impari al compito di raccontare questa storia, sono stato felice di raccontarla, non da ultimo perché a livello di fonti, visive e testuali, tanto è cambiato nel corso degli ultimi decenni. Ritrovamenti archeologici, soprattutto iscrizioni del periodo biblico, hanno dato un'idea nuova di come quel testo, divenuto patrimonio di gran parte dell'umanità, sia venuto alla luce. Da un capo all'altro del mondo ebraico si sono scoperti mosaici che modificano radicalmente non solo la nostra idea di che cosa fossero una sinagoga e il culto ebraico, ma di quanto questa religione avesse in comune nelle sue forme con il paganesimo e il cristianesimo delle origini. Senza forzare la narrazione fino a farne una favoletta consolatoria, e senza sottovalutare le tante sofferenze che l'hanno bagnata di lacrime, la storia che si racconta qui è una storia di eroismo della vita quotidiana quanto di grandi tragedie. Questo libro e questo documentario televisivo sono pieni di quelle piccole rivelazioni che, il prosaico accanto al poetico, danno il senso di una cultura: uno scarabocchio su una pagina di esercizi di ebraico di un bambino del Cairo medievale; una battaglia fra gatti e topi su una Bibbia spagnola sontuosamente miniata; la dote di commovente povertà portata da una schiava egizia del V secolo a.C. nell'andare sposa a un funzionario del locale tempio ebraico; l'aggravarsi della situazione vista da un ufficiale in ansiosa attesa in una fortezza su una collina, man mano che i babilonesi avanzano; le risonanti parole della benedizione sacerdotale incise in ebraico arcaico su un minuscolo amuleto d'argento risalente al regno di Giosia.
Banale vita quotidiana. Ma la storia degli ebrei è stata tutto tranne che banale. Ciò che gli ebrei hanno vissuto, e sono in qualche modo sopravvissuti per raccontare, è la versione più intensa nota alla storia umana di avversità subite anche da altri popoli; una versione che parla di resistenza perenne di una cultura al suo annientamento, di ricostruzioni di case e habitat, di una prosa e poesia della vita scritte nel succedersi di sradica-menti e aggressioni. È questo a rendere tale storia particolare e universale a un tempo, eredità comune di ebrei e non ebrei allo stesso modo, un'immagine della nostra comune umanità. In tutto il suo splendore e la sua degradazione, le sue ripetute tribolazioni e la sua infinita creatività, la storia riportata nelle pagine che seguono rimane, per tanti e tanti versi, una delle grandi meraviglie del mondo.
ESTRATTO DAL PRIMO CAPITOLO
IN EGITTO
In principio — non il principio immaginato da patriarchi e profeti, e certamente non il principio dell'intero universo, solo il principio documentato degli ebrei comuni — in quel principio, un padre e una madre erano preoccupati per il figlio.
Il ragazzo, un soldato, si chiamava Shelomam, versione aramaica del mio nome ebraico, Shelomo. Il nome di suo padre era Osea, secondo nome del mio aba. I Da allora sono passati due millenni e mezzo. Era il 475 a.C., il decimo anno del regno di Serse, re achemenide di Persia che, sebbene copertosi di sangue in Grecia, dominava ancora l'Egitto, dove Shelomam e Osea vivevano. Serse sarebbe rimasto sul trono un altro decennio prima di essere assassinato dal suo più fido ufficiale, Artabano Ircano, con la complicità di un eunuco. Gesù di Nazaret non sarebbe nato che mezzo millennio dopo. A credere ai diversi autori della Bibbia ebraica, erano passati circa ottocento anni da quando Mosè aveva guidato gli israeliti schiavi dall'Egitto nelle montagne del deserto dove, in possesso delle leggi ricevute direttamente da Yahweh, anzi, scritte con il Suo stesso dito, si erano mutati, malgrado ricorrenti flirt con l'idolatria e la smania di avere tanti altri dèi, in qualcosa di simile a ebrei.
L'esodo dalla valle alluvionale del Nilo, la fine della schiavitù straniera, fu presentato dagli autori biblici come la condizione per divenire pienamente israeliti. Essi immaginarono il viaggio come un'ascesa, sia topografica sia morale. Era su alture pietrose, tappe sulla via che porta in cielo, che YHWH, come Yahweh era scritto, aveva rivelato Se stesso (o almeno la Sua schiena), rendendo il volto di Mosè caldo e splendente di radiosità riflessa. Fin dall'inizio (sia nella versione biblica sia in quella archeologica), gli ebrei furono gente di collina. In ebraico, emigrare in Israele è ancora aliyah, un salire. Gerusalemme era inimmaginabile nella bassa pianura fluviale. I fiumi erano torbidi di tentazioni; il mare era ancora peggio, traboccante di mostri coperti di squame. Coloro che ne abitavano le rive o ne solcavano le onde (come i fenici e i greci) erano da detestare come gente losca, idolatra e immonda. Tornare in Egitto allora, agli occhi di coloro per i quali l'esodo era l'appropriato avvio di qualunque cosa fosse ebraica, era una caduta, una discesa nella sfacciata idolatria. I profeti Ezechiele e Geremia, quest'ultimo anche dopo essere andato in Egitto egli stesso, avevano messo in guardia contro questa ricaduta, questo disebraicizzarsi. Coloro che avrebbero ceduto, ammoniva Geremia, sarebbero divenuti «oggetto di esecrazione, di orrore, di maledizione e di scherno».
-
-
-
-
-
-
36,00 €→ 34,20 € -
-
-
-
-
-
-
36,00 €→ 34,20 € -
-
-
-
-
40,00 €→ 38,00 €
-
29,90 €→ 28,40 € -
-
-
-
-
-
-
18,00 €→ 17,10 € -
29,90 €→ 28,40 € -
-
-
-
-
-
-
18,00 €→ 17,10 € -
29,90 €→ 28,40 €










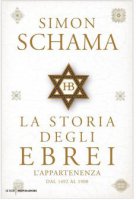







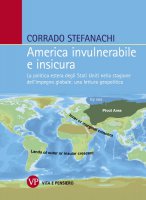
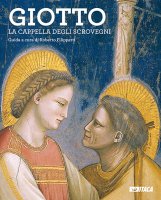



![Storia della religione nell'Israele antico [vol_1] / Dalle origini alla fine dell'età monarchica - Albertz Rainer](https://img.libreriadelsanto.it/books/w/WiXH7spweQbH-m.jpg)





























