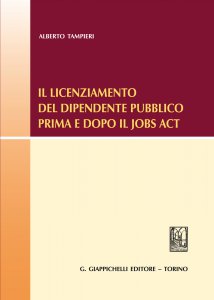Il licenziamento del dipendente pubblico, nell’ambito della costante evoluzione della disciplina del pubblico impiego, è argomento di grande attualità; esso si inserisce in un più ampio dibattito, in atto ormai da tempo, sugli strumenti più adeguati per consentire alla pubblica amministrazione di recuperare efficienza e produttività, tra i quali, appunto, la possibilità di licenziare “liberamente” i dipendenti pubblici “nullafacenti”.Un rinnovato interesse per l’argomento è sorto a seguito dell’emanazione della legge n. 92/2012 (c.d. riforma “Fornero”). Quest’ultima infatti, intervenendo sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ha riaperto un interessante dibattito – che sembrava ormai tendenzialmente consolidato, almeno in giurisprudenza – sulle conseguenze dell’eventuale illegittimità del recesso intimato dalla pubblica amministrazione, e in particolare sull’applicabilità dell’art. 18 al lavoro pubblico. Ci si è chiesti, sin dai primi commenti, se l’art. 18 dello Statuto, unica norma che disciplina le conseguenze dell’illegittimità del recesso nell’ambito del lavoro pubblico (v. infra), debba trovare applicazione nella sua versione novellata o in quella antecedente alla legge Fornero (infra, cap. III). Infatti, stando alla previsione dell’art. 1 della legge n. 92/2012, le innovazioni apportate dalla riforma non dovrebbero essere immediatamente applicabili anche al lavoro nella pubblica amministrazione; la giurisprudenza però, come si vedrà, si è orientata in senso diverso.Una ulteriore difficoltà interpretativa, forse ancor più ardua della precedente, si è creata a seguito dell’emanazione della recente delega legislativa in materia di lavoro (legge 10 dicembre 2014, n. 183; c.d. Jobs Act), che ha avuto una prima, rapida attuazione, mediante il decreto delegato n. 23/2015 in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e nuova disciplina dei licenziamenti. La legge delega, nella parte dedicata alla revisione della disciplina del recesso individuale (art. 1, comma 7, lett. c) non chiarisce affatto il punto relativo all’applicazione al pubblico impiego delle nuove tutele per il lavoratore illegittimamente licenziato: tutele che prevedono, rispetto al (recente) passato, e cioè alle modifiche del 2012, il contenimento della reintegrazione ad ipotesi specifiche e l’espansione della garanzia meramente risarcitoria.Non essendovi alcuna previsione nella legge delega n. 183/2014, era prevedibile che nemmeno il decreto delegato si esprimesse sul punto, probabilmente per evitare il rischio di eccedere dalla delega ricevuta; e tuttavia, la circostanza che il Governo abbia disatteso il suggerimento, contenuto nel parere della Commissione parlamentare, di esplicitare l’esclusione del pubblico impiego (v. infra, cap. III) mostra chiaramente che l’orientamento del legislatore è stato quello di regolamentare la materia limitatamente al lavoro nell’impresa privata.Tuttavia è indubbio che la mancanza di precise indicazioni in materia abbia incrementato ulteriormente le incertezze interpretative: ciò nondimeno, l’opportunità di avere una disciplina certa e inequivocabile per le conseguenze dell’illegittimità del recesso individuale dal contratto di lavoro nel settore pubblico è molto evidente, se si considera che la più recente legislazione in tema di contenimento del costo del personale pubblico ha inserito – talora in contesti non appropriati – ulteriori ipotesi di licenziamento individuale di carattere “oggettivo”.Ad esempio, è stato lasciato alle amministrazioni un margine di intervento, più o meno ampio, al fine di far cessare unilateralmente rapporti di lavoro di dipendenti che siano già in possesso dei requisiti pensionistici (cfr. cap. II). In quest’ultimo caso, peraltro, il più recente indirizzo legislativo, volto ad eliminare completamente la reintegrazione nel posto di lavoro per i licenziamenti economici, non troverà applicazione, non fosse altro per la circostanza che il recesso per raggiungimento della massima anzianità contributiva non può certamente riguardare nuove assunzioni (art. 1, d.lgs. n. 23/2015).Nonostante l’importanza del tema, nelle ormai numerose trattazioni dedicate al lavoro pubblico “contrattualizzato” da parte della dottrina giuslavoristica (accanto a quelle di elaborazione giuspubblicistica), non sempre è dato riscontrare una parte espressamente e diffusamente dedicata al tema del licenziamento del pubblico dipendente. Anche nella manualistica specifica di settore, sebbene ampia e qualificata, la trattazione si riduce di consueto a poche pagine, sostanzialmente prive di commento.Questa situazione è forse dovuta, innanzitutto, al convincimento – tuttora assai diffuso anche tra gli addetti ai lavori – che il licenziamento del dipendente pubblico sia ancora un’ipotesi numericamente marginale e concretamente difficile da attuare. Eppure, una simile opinione, se può avere qualche fondamento nell’ambito di una comparazione tra lavoro pubblico e privato, non è del tutto vera in termini assoluti; è anzi un luogo comune, come tale privo di sostanza nella sua generalizzazione, quello secondo il quale non è possibile licenziare nella pubblica amministrazione.In secondo luogo, la scarsità di contributi specifici sul licenziamento del pubblico dipendente deriva dal fatto che la stessa normativa generale sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni, e cioè il noto d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non contiene un’organica disciplina delle cause di risoluzione del rapporto di lavoro pubblico e in particolare del licenziamento individuale.È pur vero, peraltro, che dopo l’entrata in vigore della riforma “Brunetta” (d.lgs. n. 150/2009), vi è ora una specifica e controversa norma, sebbene non esaustiva, sul licenziamento disciplinare del lavoratore non appartenente ai ruoli della dirigenza (art. 55-quater, d.lgs. n. 165/2001, sul quale pure si v. diffusamente infra).La ragione di una simile scelta legislativa, adottata nel 2009, è da riscontrarsi nella presenza della norma-quadro di cui all’art. 2, comma 2 dello stesso decreto n. 165/2001 (anch’essa riformata dalla legge delega n. 30/2009), la quale, com’è noto, estende, in linea generale, al lavoro pubblico le regole vigenti per il rapporto di lavoro subordinato nell’impresa privata. Sulla stessa linea è la netta “scelta di campo” del legislatore nel successivo art. 5, comma 2 del medesimo decreto, secondo la quale le pubbliche amministrazioni agiscono, nella gestione dei rapporti di lavoro, “con le capacità e i poteri” di un privato datore di lavoro.In questo contesto, le norme speciali dirette alla disciplina del licenziamento nel lavoro pubblico si affiancano – ma, come si vedrà, non si sostituiscono in toto – alle norme generali in materia di recesso dal rapporto di lavoro. In particolare, se è un dato assodato quello relativo all’applicabilità al lavoro nella pubblica amministrazione della disciplina “privatistica” in materia di licenziamenti e segnatamente, oltre che degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., della legge 15 luglio 1966, n. 604 (con esclusione dell’art. 8), dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a prescindere dal numero dei dipendenti (art. 51, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), e finanche della legge 11 maggio 1990, n. 108 , nulla si dice, come si è visto, a proposito della riforma dei licenziamenti attuata tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015.Sicura è invece l’esclusione, dalla disciplina “privatistica” dei licenziamenti, del personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3, d.lgs. n. 165/2001 (magistrati, avvocati dello Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia, e altre categorie ancora), il quale rimane assoggettato alla disciplina prevista dagli specifici ordinamenti di settore anche per quanto riguarda gli aspetti sostanziali e procedurali dell’eventuale recesso dell’amministrazione.Tornando per un momento alle specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare introdotte nel contesto del d.lgs. n. 165/2001 ad opera del citato decreto n. 150/2009, è stato detto che la “maggiore originalità” di tali norme sta “nel delineare ipotesi specifiche di licenziamento, distinguendo per legge anche la causale giustificativa cui ciascuna va ricondotta, e, soprattutto, nella previsione, in alcuni casi, di un vero e proprio obbligo di licenziare” .È indubbio che in questo caso si manifesti una precisa linea di tendenza legislativa orientata nel senso di affidare alla fonte legale la materia disciplinare e in particolare del recesso, mediante previsioni inderogabili da parte della contrattazione collettiva. L’operazione non era sconosciuta anche nella normativa speciale del pubblico impiego precedente al 2009, dove era dato riscontrare ipotesi legalmente “predeterminate” di licenziamento per ragioni disciplinari, ad esempio in materia di incompatibilità, cumulo di incarichi e part-time (legge n. 23 dicembre 1996, n. 662, sulla quale pure v. infra); questo modo di operare del legislatore va tuttavia in controtendenza rispetto al principio generale della “privatizzazione” del rapporto di lavoro pubblico, di cui si è detto in precedenza, creando un effetto di “deriva” del lavoro pubblico rispetto a quello privato (cap. III, sezione I).A completamento di queste brevi note introduttive, è opportuno precisare che non verrà trattata in questa sede la disciplina delle eccedenze collettive di personale nelle pubbliche amministrazioni (cfr. artt. 33 ss. del d.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, l’art. 2, comma 11 del d.l. n. 95/2012 e gli artt. 4 e 5 del d.l. n. 90/2014). Nemmeno si farà riferimento al conseguente collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici in esubero, fatta eccezione per l’ipotesi, completamente diversa quanto a finalità e presupposti, della collocazione in disponibilità quale sanzione disciplinare (sulla quale si v. il cap. I).Si tratta di una scelta sistematica, derivante dalla constatazione che la disciplina delle eccedenze collettive è sensibilmente divergente rispetto a quella privatistica, oltre che complessa al punto tale da risultare del tutto ineffettiva. Va dato atto però che il legislatore più recente, con il d.l. n. 90/2014, poi convertito dalla legge n. 114/2014, ha tentato nuovamente di rilanciare il tema della mobilità volontaria tra amministrazioni o, in alternativa, della mobilità obbligatoria, spingendosi sino ad affermare – con una norma assai discutibile – che “le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell’art. 2103 cod. civ.”, e aggiungendo che “parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito” (art. 4, comma 2, d.l. n. 90/2014).Un accenno verrà comunque dedicato, nel quadro delle ipotesi “oggettive” di cessazione individuale del rapporto di lavoro, al licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore, che come in altri casi ha ottenuto, in sede legislativa, una norma speciale dedicata al lavoro pubblico (art. 55-sexies, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009).