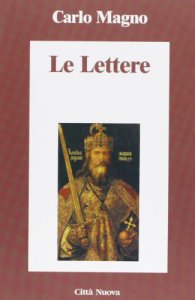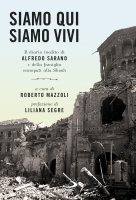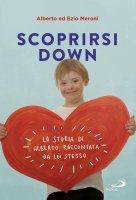PREFAZIONE
di Franco Cardini
È stato davvero "un padre dell'Europa", Carlo Magno? Tale è il sottotitolo della biografia che gli ha di recente dedicato Alessandro Barbero. E tale è tutto sommato anche il mio parere, per quanto io sia ben lungi purtroppo da poter vantare al riguardo competenze specifiche.
Sul fatto che la nostra patria europea possa davvero annoverare, tra i suoi padri storici, anche il grande sovrano franco, esiste una lunga discussione. Già Ernesto Sestan, sia pure con qualche riserva, si schierava sulla negativa: e osservava che l'Europa, nelle diversificazioni e nella molteplicità che ne sono caratteri originali — l'"arcipelago europeo", a dirla con Massimo Cacciari —, è figlia più della dissoluzione dell'impero carolingio che non della sua fondazione. Oltre una ventina di anni fa emersero, durante un convegno tenuto a Spoleto nel 1979, le differenti e quasi opposte posizioni al riguardo espresse da due studiosi entrambi illustri: Karl Ferdinand Werner, che almeno per quanto attiene l'aspetto politico-istituzionale dichiarava legittimo il considerare l'età carolingia come il nucleo generatore dell'Europa medievale — e dunque anche, nel tempo, di quella moderna e della nostra —; e Robert Fossier, secondo il quale (e quanto meno sotto l'aspetto economico) un rapporto del genere non sarebbe immediatamente istituibile.
Eppure, col procedere degli anni e col rafforzarsi delle istituzioni e (con maggior lentezza) dei sentimenti comunitari che non senza difficoltà ci stanno conducendo verso l'unità europea, notiamo che i nostri pensieri vanno sempre più spesso a Carlo come a un Pater Patriae: a uno dei Patres, se non proprio e addirittura all'unico. Il milleduecentesimo anniversario della sua incoronazione, nel 2000, ha rafforzato questa tendenza provocando, fra l'altro, una nutrita serie di biografie, di esposizioni, di convegni di studio. Siamo insomma usciti dal tempo della retorica celebrativa: e ci andiamo ormai interrogando in termini di precisa memoria storica, di identità e di coscienza di essa.
È forse questa la prospettiva più giusta per rileggere, nella traduzione fornitane e con le note critiche proposte da Dag Tessore, queste ventiquattro lettere di Carlo redatte durante l'intero arco o quasi del suo lungo regno: da quella ad Offa re di Merda (di datazione incerta, poiché si riferisce a due ,fatti avvenuti a oltre un decennio l'uno dall'altro, cioè nel 774 e nel 785) a quella al basileus Michele nell'813.
Non starò qui a ripetere quel che più volte è stato detto, e che del resto lo stesso Tessore richiama nella sua Nota iniziale, a proposito del genere epistolografico tra VIII e IX secolo, del ruolo coperto dagli scambi epistolari nella cultura e nella diplomazia del tempo, delle cognizioni e dell'abilità di Carlo come epistolografo e come "scrittore". È noto che Carlo era senza dubbio alcuno — e al di là delle opere che gli sono state attribuite, e di che cosa significasse, nel suo tempo, essere "autore" — un uomo colto: nel senso che amava le questioni legate a molti aspetti del sapere, che usava ascoltare le dispute fra i dotti riuniti nella sua corte e prendervi anche parte, che era abituato a farsi leggere lunghi passi delle Scritture e di opere teologiche, scientifiche e letterarie ed era anche in grado di leggerle direttamente.
Un quadro che senza dubbio consente di poter definire colto un regnante dell'VIII-IX secolo detentore di questi interessi e di queste capacità. Il sapere scrivere non era affatto immediatamente e necessariamente collegato né agli uni, né alle altre: esso era una forma di attività tecnica a carattere specialistico, considerata propria oltretutto anche di determinate categorie di persone; attività onorevole e raffinata del resto, magari circondata di rispetto e di un alone quasi magico (il rapporto fra scrittura, sacralità e magia è noto, e precede di parecchio il cristianesimo), tipica peraltro di esecutori, di funzionari, di chierici, di subalterni. Ancora per molti secoli sarebbe stato considerato impensabile, bizzarro, disdicevole per un sovrano lo scrivere direttamente qualcosa: e in un certo senso, a livello pubblico e ufficiale, tale mentalità permane ai nostri giorni, fatte le debite differenze tecniche e culturali.
Ma Carlo, che senza dubbio non scriveva materialmente le "sue" lettere, almeno le dettava, con tutta la densità di significato concettuale e stilistico che nel suo tempo si attribuiva alla parola, appunto, dictare?
Certo, le "sue" lettere non erano tali nello stesso senso in cui erano dei rispettivi autori, reali o immaginari, quelle di Iacopo Ortis o di Simone Weil. Ma neppure nel senso in cui ad Abelardo e ad Eloisa apparteneva il loro celebre epistolario. Il confronto — nella consapevolezza che i confronti non sono mai perfetti — va fatto semmai con le lettere che ancor oggi si scambiano talvolta i capi di Stato in appoggio e a complemento di scelte politiche e diplomatiche. Le lettere di Carlo erano frutto di un'idea di base che senza dubbio apparteneva quasi più o meno tutta al sovrano; ma anche di circostanze e di fasi di elaborazione in cui a vario titolo entravano consiglieri e funzionari prima che si passasse alla fase stilistica e materiale della vera e propria stesura.
Non è dunque la traccia del sentire di Carlo che va seguita in queste lettere. Esse sono semmai il segno e il frutto di un'attività di governo e anche, talvolta, di un pensiero che va oltre la politica, fino a toccare la fede, la morale, magari l'estetica. Che poi, al di là della pubblica persona e del filtro costituito dai consiglieri, dagli accorgimenti stilistici e retori ci, dagli scribi, dai copisti e magari dagli editori e dai traduttori moderni, il lettore abbia qua e là anche la sensazione d'intravedere qualcosa del "vero" Carlo, di lui come persona diciamo così privata, è cosa dinanzi alla quale — quand'essa insorga — lo storico e il filologo non possono non reagire invitando alla prudenza. Ma non è detto che talora il lettore magari non medievista, magari perfino ingenuo e sprovveduto, non riesca a vedere in modo più profondo e più acuto dello specialista. Semmai, è difficile se non impossibile, in casi del genere, dimostrare che ciò sia avvenuto.