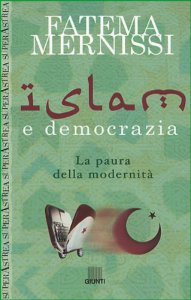Fatema Mernissi, nata a Fez in Marocco nel 1940 e attiva nel mondo universitario francese e marocchino come sociologa, è soprattutto nota come autrice di romanzi e memorie al femminile (La terrazza proibita). Nella produzione saggistica ha lavorato a fondo per far emergere una coscienza e una identità araba al femminile - compito di cui si avvertiva l’urgenza in Occidente non meno che nell’Oriente musulmano - nell’ottica dell’emancipazione della donna musulmana (L’Harem e l’Occidente, Le donne del profeta, Charazad non è marocchina, Le sultane dimenticate).
Con questo suo libro profondo e appassionato l’Autrice affronta un tema diverso, ma quanto urgente e attuale non occorre certo dimostrarlo. Il sottotitolo («la paura della modernità») ci fornisce un prezioso filo conduttore della sua analisi del tema, che si dipana attraverso densi capitoli dai titoli autoesplicativi: 1. Paura dell’occidente straniero; 2. Paura dell’imam; 3 Paura della democrazia; 4. La Carta delle Nazioni Unite; 5. Il Corano; 6. Paura della libertà di pensiero; 7. Paura dell’individualismo; 8. Paura del passato; 9. Paura del presente, 10. Il canto delle donne: destinazione libertà.
A scorrere questo elenco di paure, ci si chiederà: ma come, non eravamo noi, occidentali, quelli che hanno paura? Se si pensa appunto alla «paura dell’islam» che domina il dibattito e l’immaginario occidentali da qualche decennio a questa parte, c’è da giungere stando all’analisi della Mernissi a una prima conclusione: forse l’islam teme l’Occidente assai più di quanto quest’ultimo non tema l’islam. L’analisi della Mernissi, la cui lucidità magari è qualche volta disturbata un po’ dall’ideologia, è davvero impietosa e non fa sconti di sorta al proprio mondo, alle proprie radici. Ma non è un’analisi disperata, al contrario. La Mernissi innanzitutto compie una operazione di tipo filologico, analizzando il vocabolario religioso (o politico-religioso) fondamentale del mondo islamico, soffermandosi con finezza di osservazioni e ampiezza di documentazione su concetti quali: jadal (discussione ‘dialettica’), gharb (occidente), imam (capo religioso), ta’a (obbedienza), ra’y (libera opinione), hukm (potere-giudizio-forza), ‘adala (giustizia), zulm (oppressione, tirannia), khayal (immaginazione), hurriyya (libertà), hijab (velo, velatura), kufr (miscredenza), shiqaq (scisma), hizb (fazione, partito), salam (pace), fitna (ribellione, tentazione), musawat (uguaglianza), rahma (misericordia), jumhuriyya (repubblica), ra’is (presidente, capo politico) e molti altri ancora. Qui sta certamente uno dei motivi di interesse - forse il maggiore a parere di chi scrive - del volume, che ci consente di visitare il vasto repertorio del lessico politico-religioso musulmano e che, soprattutto, attraverso questa attenta esplorazione linguistica ci porge una affascinante ‘archeologia’ del sapere e delle forme del sapere in terre arabo-islamiche.
Riassumere in poche righe l’analisi della Mernissi è qui impossibile, ma è d’obbligo almeno sottolineare uno dei capisaldi del suo ottimismo: la sopravvivenza attraverso i secoli, spesso secoli bui, di un «umanesimo» musulmano che ha avuto i suoi pilastri - a volte indeboliti ma mai abbattuti - nella tradizione filosofica che si nutrí ampiamente del lascito greco. Un lascito che fu originalmente reinterpreto e ‘riconsegnato’ poi con sostanziosi interessi alla Scolastica attraverso i ben noti commenti di Avicenna e Averroè ai filosofi greci, attraverso l’arricchimento decisivo portato alla scienza medica, l’astronomia, la farmacia, la matematica, l’ottica, l’alchimia, qualcosa che - a parere quasi unanime degli storici del pensiero - fecondò ampiamente il nascente Umanesimo europeo. Ma questo umanesimo musulmano che - secondo un’idea ampiamente diffusa tra gli intellettuali musulmani odierni - addirittura «incuba» quello successivo dell’Occidente europeo, non si limita alla ricca tradizione filosofico-scientifica, che spesso dovette peraltro misurarsi con accuse di eresia o blasfemia; questo umanesimo è fatto anche di una straordinaria tradizione letteraria e soprattutto poetica che, in barba alla condanna coranica della poesia («I poeti… sono i traviati che li seguono... non vedi come vanno di valle in valle dicendo quel che non fanno?», II, 224-26), affermerà nei secoli valori tipicamente «umani» spesso in contrasto con il codice religioso (il vino, l’amore libero) e una Stimmung di tono irriverente ai limiti della iconoclastia che configura una vasta tradizione di ‘libero pensiero’ di schietta marca laicheggiante o talora persino ateistica. Ma questo umanesimo musulmano, in forme ancora diverse, ha modo di svilupparsi anche nella ricerca teologica a partire dall’epoca del movimento della Mu’tazila (nella Baghdad califfale del IX secolo) che nell’esegesi sacra affianca al primato indiscusso del dettato scritturale il criterio dell’analisi razionale ovvero il ruolo insopprimibile della ‘ragione’ (‘aql), qualcosa che ritornerà più tardi nella prassi esegetica del vasto fenomeno del Modernismo/Riformismo musulmano tra ’800 e ’900.
Volendo un po’ sintetizzare, la Mernissi vede nella lotta perenne tra il principio di autorità (basato sulle scritture sacre) che esige ‘obbedienza’ (ta’a) incondizionata e piena sottomissione, e il principio di libertà che esige invece l’esercizio della ‘ragione’ (‘aql) e della ‘libera opinione’ (ra’y), uno dei nodi della storia dell’islam, che peraltro si ripropone continuamente dal medioevo a oggigiorno nello sviluppo del pensiero teologico e giuridico in particolare. I musulmani (le loro élites), questa è la tesi forte dell’A., hanno sempre temuto che autorizzare un troppo libero esercizio del ra’y portasse inevitabilmente a conseguenze perniciose per la Umma o comunità religiosa: allo ‘scisma’ (shiqaq), alla ‘ribellione’ (fitna), alla perdita della pace comunitaria, come peraltro la storia islamica ampiamente dimostrerebbe a partire dalle infinite lotte tra sciiti e sunniti che, sia pure attutite, ancor oggi riemergono qua e là. Per amore della pace interna alla Umma troppo spesso, lamenta la Mernissi, il dibattito e la libera ricerca sono stati soffocati; troppo spesso i governanti -anche dopo la fine del colonialismo - hanno represso il nuovo che emergeva dalla società (richiesta di libertà, di democrazia) bollandolo come fitna, ossia ribellione in senso religioso, come minaccia alla pace interna. Significativo in questo contesto, apriamo qui una parentesi, è il concetto teologico di bid’a, ossia ‘innovazione’ potenzialmente eretica e dunque sempre carica di una significato tendenzialmente negativo: è un concetto che comunemente definisce ogni nuova idea in campo religioso. E qui forse la Mernissi omette di metter in più chiaro risalto una peculiarità della formazione del dogma e dell’ortodossia in ambiente islamico. Non un papa, né un concilio, decidono in proposito, bensí la lenta talora secolare formazione di un ‘consenso’ (ijma’) qualificato, ossia di un consenso dei dottori, intorno a tesi che all’origine erano immancabilmente qualificate appunto come pericolose bid’a. Questo aspetto, ossia la discussione fra scuole e indirizzi teologici (o giuridico-teologici) a colpi di pamphlet, di trattati e confutazioni - che provocavano ovviamente repliche e controrepliche all’infinito - di tesi controverse, portava in tempi più o meno lunghi alla definitiva emarginazione come ‘eresia’, oppure al contrario all’inglobamento nel ‘credo’ (‘aqida), della tesi innovativa che aveva scatenato la controversia, insomma portava alla formazione di un nuovo ‘consenso’ e di una nuova ortodossia. Ebbene, è forse proprio questa forma eminentemente comunitaria di formazione di una ortodossia - caratterizzata da un fitto dibattito, spesso animatissimo ma sostanzialmente libero, tra scuole e indirizzi opposti - che contiene a mio parere, in germe, un nucleo importante di quella ‘democrazia’ in salsa autoctona che il mondo arabo non ha mai saputo poi sviluppare; tant’è che l’arabo non ha questa parola, ma usa un neologismo importato dalle lingue occidentali ossia dimukratiyya.
Le forme di democrazia importate dall’Occidente, lamenta la Mernissi, hanno sempre spaventato per la loro potenziale delegittimazione della tradizionale acquiescenza delle masse al potere politico-religioso, informata al principio dell’obbedienza (ta’a) alle autorità e volta alla preservazione del ‘bene sommo’ della pace interna. I fondamentalisti odierni - consapevoli della sfida portata dall’Occidente - hanno proposto una versione autoctona della ‘democrazia’ basandosi sul concetto coranico di shura, termine che designa la ‘consultazione’ dei propri compagni e fedeli da parte del profeta Maometto alla vigilia delle decisioni importanti; visione che evidentemente non recepisce molto della democrazia occidentale, essendo la decisione politica lasciata non nelle mani dei rappresentanti eletti della sovranità popolare, bensí nelle mani della ‘guida’ religiosa - sia pure tenuta a consultarsi - ossia l’interprete dell’unica vera sovranità riconosciuta in questi ambienti, quella di Allah. I fondamentalisti, in altre parole, secondo un paradigma condensabile nell’idea di “islamizzare la Modernità”, propongono una versione appunto islamica della democrazia. Qui siamo al cuore del problema: la ‘sovranità’ (hakimiyya) dal punto di vista dei religiosi tradizionalisti e fondamentalisti formatisi sul Corano e sul Hadith appartiene solo a Dio; il ‘califfo’ (etimologicamente: vicario/rappresentante) la esercita in terra sulla comunità solo come ‘vicario’ di Dio. Gli stessi principi musulmani del medioevo, a partire da questa impostazione che delegittimava in partenza ogni potere terreno, si proponevano come ‘spada della fede’ o ‘supporto della fede’, quasi a giustificare la propria posizione. L’idea poi di una ‘sovranità’ del popolo che la esercita nelle forme legali della rappresentanza è sostanzialmente estranea alla cultura religiosa tradizionale, benché tutto l’Islam modernista/riformista dall’‘800 in poi l’abbia fatta propria e abbia tentato – spesso eroicamente- di realizzarla.
Altro tema importante, sottolineato dall’Autrice, è la centralità del discorso religioso sia nella retorica dei governanti che in quella degli antagonisti: in concreto, negli odierni paesi arabo-musulmani sia il potere (si colori o meno di una vernice liberale o ‘democratica’), sia l’opposizione (ieri socialista, oggi fondamentalista) fanno ricorso sistematico a categorie e concetti del lessico religioso, rivelando spesso quanto superficiale possa essere stata l’assimilazione del lessico (e della prassi) della democrazia all’occidentale e, in generale, delle ideologie politiche di origine europea.
Tuttavia, e qui sta certamente un equivoco cui a mio parere soggiace la stessa Mernissi, parlare di un Islam che ha semplicemente «paura della modernità» può essere riduttivo e persino fuorviante, almeno se si guarda non tanto agli ultimi decenni quanto a quello che è avvenuto in terre islamiche da metà ’800 sino agli anni ’70 del secolo or ora conclusosi. A ben vedere l’Islam non ha fatto, in questo periodo che rincorrere l’Occidente sotto ogni aspetto. Nel periodo delle Tanzimat («riforme» degli anni 1820-40) l’Impero Ottomano importava tecnici, scienze e modelli occidentali per modernizzare le sue strutture amministrative, finanziarie e militari; nella seconda metà dell’‘800 esplodevano i movimenti costituzionalisti che porteranno tra fine ’800 e inizi del ’900 a grandi rivoluzioni liberal-costituzionali, all’avvento dei parlamenti, alla promulgazione di costituzioni e nuovi codici civili e penali di stampo europeo; nella prima parte del ’900 è l’era dei partiti nazionalisti che prima lottano per l’indipendenza e poi impongono forme di stato centralizzato in precario equilibrio tra ideali liberali e politica autoritario-paternalistica; tra le due guerre poi si aggiungerà il modello ‘social-nazionalista’, che guarda all’Italia fascista e persino alla Germania nazista come a esempi insuperati della Modernità, e che avrà nella Turchia di Ataturk e nell’Iran di Reza Pahlavi stuoli di ammiratori; nel secondo dopoguerra esplode infine il ‘socialismo arabo’ di Nasser che si afferma in Egitto negli anni ’50, e a ruota contagia l’Irak e la Siria, l’Algeria, la Libia… Insomma, si può davvero affermare che l’Islam ha avuto «paura della modernità», se invero non ha fatto altro tra XIX e XX secolo che riproporre in versioni autoctone e magari spesso pasticciate tutti i paradigmi politici - spesso i più fallimentari - dell’Europa coeva?
In conclusione, una lettura altamente stimolante, che parte da una analisi priva di pregiudizi e estremamente onesta di problemi e prospettive della democrazia nel mondo islamico.
Tratto dalla rivista "Studia Patavina" 2009, nr. 3
(http://www.fttr.it/web/studiapatavina)