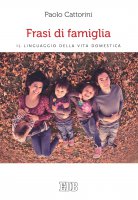Questo libro è un'avventura nel significato profondo e multiforme della parola «cura», in un arco che attraversa quotidianità, pratica medica, mito, filosofia e Scrittura.
ESTRATTO DALLA PRIMA PARTE
Parole segrete di cura
Hanna è una giovane operaia, con problemi di udito, che decide di partire e assistere Josef su una piattaforma petrolifera. Josef si è ustionato ed è ora cieco. Hanna lo accudisce con competenza. Josef deciderà di incontrarla, dopo la guarigione, per guardarla finalmente negli occhi. Chi è realmente Hanna? Che cosa ci faceva in fabbrica? Di quale patologia auricolare soffriva? Sembra che Hanna tragga piacere e giovamento dai lunghi discorsi e dalle impertinenti domande di Josef, che vuole sapere subito di lei, come è fatta, che cosa pensa, come è giunta a lui. L’alleanza che si stabilisce tra i due prende la forma di una cura reciproca: la cecità di lui addomestica il pudico riserbo di lei, che teme la violenza dello sguardo. La sordità le consente di rifugiarsi in uno spazio mentale, isolato e solitario come l’impianto di trivellazione costruito sulle acque. Ma questo rifugio è benefico anche per Josef, che avverte in quei delicati, ritrosi gesti assistenziali una risposta ai propri turbamenti, al trauma, a dilemmi mai risolti.
Le parole si fanno strada a fatica nel cemento-acciaio sferzato dal vento e sfidano le forze di un mare incombente, ostinatamente ondoso, prima di prendere le forme di un’imprevista amicizia. Le parole hanno una vita segreta: puoi dimenticarle o fraintenderle, ma lasciano comunque un segno nella mente. Sono una bava dolce o irritante sul corpo. Con le parole bisogna fare i conti. È una donna, Isabel Coixet, a dirigere Sarah Polley e Tim Robbins nel film spagnolo La vida secreta de las palabras (La vita segreta delle parole, 2005). È una donna, Hanna, a sfidare il mondo maschile degli operai del petrolio. Ed è ancora una donna, Cura, la protagonista della favola annotata da Igino, il mitografo romano del II secolo dopo Cristo.
Cura attraversa un fiume, vede del fango e comincia a dargli forma. Cura è pensierosa. Plasma la creta, prima di sapere con precisione che cosa sta portando all’essere. Mentre se lo domanda, Giove e Terra le si avvicinano. Cura chiede a Giove di donare il suo spirito di vita. Giove acconsente, ma vieta che Cura possa dare il proprio nome alla «cosa». Giove vorrebbe invece imporle il proprio. Ma anche Terra, che del resto aveva offerto parte del suo corpo, eleva analoghe pretese. Come mediare il conflitto? Scegliendo un terzo soggetto, Saturno, giudice equo, che sentenzia così. Dopo la morte, Giove ne prenderà l’anima e la Terra il corpo, ma Cura ha fatto questo essere per prima e quindi lo possiederà finchè esso vive. Altra decisione di Saturno: si chiamerà homo in quanto tratto dall’humus.
Che cosa hanno a che fare tra loro il mito, il film e l’attitudine di accudire? Che rapporto esiste tra i gesti di cura e la verità dei personaggi, i loro nomi e destini? Scioglieremo uno alla volta i fili di questo gomitolo, che ci è ruzzolato tra i pensieri. Ma prima di farlo, accenniamo a un altro incontro memorabile. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 10, versetto 25, un malizioso dottore della legge, tutto intento a giustificare se stesso, interroga Gesù su come acquistare la vita eterna e su chi sia il suo prossimo. Gesù non cade nella trappola delle definizioni teoriche e dei precetti a buon mercato. Racconta invece una storia assai istruttiva, quella del buon samaritano, e alla fine è lui a ribaltare la domanda: quale dei personaggi è stato il prossimo per il povero viandante percosso e derubato? Il colto interlocutore ha inteso e risponde: colui che ebbe compassione! L’esperimento mentale è riuscito. Gesù ha rimesso al giusto posto le categorie concettuali e le ha collocate nel contesto di una narrazione coinvolgente. Come a dire: prima ascolta o racconta una storia, poi capirai il significato dei nomi che usi e potrai pretendere una definizione vera. Il sapiente è pronto per ricevere il suggerimento decisivo: «Va’, e anche tu fa’ così» (v. 37). I dottori della legge sono a volte vittime del loro mestiere e idolatrano la legge, la legge – s’intende – dei dottori. Gesù spezza questa falsa devozione alla regola e mette in moto, grazie a un racconto, la ricerca della verità. Gesù mostra d’aver cura delle parole come ha cura dei deboli, dei violentati. I discepoli se ne ricorderanno, quando parleranno di lui, di lui come «la» Parola vivente.
Dunque tra la parola e la cura si instaura una corrente di verità. Aver cura di un paziente, come Josef, significa lasciare che i gesti si trasformino in un dialogo, attraverso cui la verità di entrambi i partner venga alla luce. Anche il gesto di Cura, che plasma il fango, cerca il senso di ciò che sta facendo e il nome di quel manufatto: parole divine lo riveleranno. La parola prolunga la cura, la completa, ma fa anche dell’altro: la corregge, la orienta. Il dottore della legge, che ha cura della propria vita («che cosa devo fare per possedere la vita eterna?»), ora conosce la parola «prossimo» e sa quel che va fatto. Le vicende di Hanna, di Cura e di Gesù mostrano quanto conti aver cura di ciò che si dice: una presentazione (l’infermiera che si qualifica davanti all’ustionato Josef), una sentenza (quella emessa da Saturno), una definizione («essere prossimo a qualcuno») sono come una materia argillosa, che va lavorata nel corso di una relazione. Senza questa fatica, persino atti premurosi possono essere fraintesi e diventare inefficaci. Viceversa, senza il contatto tra corpi, senza il calore di una comunicazione, la parola rischia l’inutilità o persino la menzogna: Hanna è misteriosamente spinta al viaggio sulla piattaforma; Cura agisce, prima di e per sapere la verità; Gesù trattiene il suo interlocutore, gli offre ospitalità dentro un racconto (la parabola del samaritano) e solo alla fine gli pone la domanda decisiva.
Se una verità accade, accade nel campo di forze teso tra cura e parole. La cura esige parole. E le parole cercano un racconto, che mostri il loro significato e le leghi lungo una trama accogliente. Quindi un’ipotesi può essere già ora espressa. Un sospetto utile al nostro lettore. Nell’incombenza del male, che può renderci sordi o ciechi, che ci deruba come fa un brigante, che fa vacillare i nostri rapporti e le nostre convinzioni, che ci strappa il dizionario con cui davamo nome alle cose, agli eventi, alla prossimità stessa degli amici, sentiamo che qualcosa, in noi e fuori di noi, si oppone alle avversità. Un racconto felice, di cui abbiamo avuto notizia, ci invita a narrare ancora la nostra vicenda, in cerca di un finale degno. Uno straniero, imprevedibilmente, lenisce le nostre ferite. Forse la passione che nutriamo per le cose è ricambiata? C’è qualcosa o qualcuno, nel mondo, interessato a noi? Mentre i pensieri inseguono una verosimile risposta e nuove emozioni ci invitano ad esplorare ancora, le nostre mani plasmano il fangoso destino, in cui ci siamo imbattuti. Ciò che è accaduto senza di noi o contro di noi, merita di venire riplasmato, di assumere un volto più umano. Cura sorregge questo impegno di giustizia. Cura è desiderare che la verità prenda forma.
Medicina e cura
La medicina cura? La medicina offre dispositivi di cura, ma si prende cura di chi soffre? Le frequenti lamentele di pazienti, associazioni di malati e degli stessi operatori sanitari segnalano, pure in contesti in cui è riconosciuto per legge il diritto all’assistenza sanitaria, una crisi etica dell’idea di medicina. Qual è la promessa che impegna un professionista sanitario? Promuovere la salute dei cittadini? Ma, da capo, che cosa significa oggi salute? Circola una nota definizione. Salute non sarebbe la semplice assenza di malattia o infermità, ma uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. Un ideale, certamente. Ma ancora proponibile? Oppure ormai corroso e illanguidito in un auspicio vago, in un mero appello retorico?
Anzitutto, a guardar bene, la salute non può essere uno stato, ma piuttosto un equilibrio dinamico in perenne oscillazione. L’organismo cerca costantemente di imporre le proprie norme a un ambiente, che gli fornisce risorse vitali essenziali, ma nel contempo lo stimola, provoca, assedia, minaccia. La salute di un vivente risiede nell’elasticità della risposta a queste perturbazioni, nella riserva energetica grazie a cui vengono inventati nuovi compromessi, nella capacità degli organi di sviluppare funzioni riparatrici, sostitutive, evolutive. L’organismo è, sin dalla biologia dei greci, un insieme di parti che si prendono silenziosamente cura le une delle altre, come sotto l’influsso di una forza unitaria di coordinamento. La salute – è stato scritto con una certa verità – è la vita nel silenzio degli organi e «guarire significa darsi nuove norme di vita, talvolta superiori alle precedenti».
Inoltre, la salute è davvero identificabile in un benessere completo? In realtà, quando pensiamo a qualcuno che sta bene, gli attribuiamo una salute buona, apprezzabile, sufficiente. Sappiamo che in noi c’è sempre, magari di nascosto, qualcosina che non va. Che farcene allora di una definizione così utopistica? Essa può risultare utile quando si parla di criteri generali per importanti decisioni etico-politiche, che fanno spesso ricorso a termini come giustizia, verità, democrazia, libertà. Purtroppo a questo lessico astratto siamo costretti a rinunciare quando misuriamo il duro mestiere di vivere. Come cittadini sappiamo di abitare mondi imperfetti, talora francamente ingiusti, falsi, dispotici, servili.
Nella misura in cui la medicina si presenta come una religione secolare, che presume di fornire risposte non solo alla domanda su «come fare», quando si sta male, ma addirittura su «perché intervenire» e «quale senso» attribuire al disagio, è comprensibile che si realizzi un esproprio da parte dei tecnici, i quali peraltro prima o poi dovranno dichiarare la loro balbettante incompetenza nell’affrontare da soli questi temi. Il profano si sentirà tradito da questa tardiva confessione di impotenza e svilupperà reazioni sfiduciate, se non addirittura aggressive. Gli esempi sono molti: la difficoltà di condividere a domicilio la fase terminale di una malattia, che colpisce un nostro familiare, non è solo dovuta alla ristrettezza fisica dell’appartamento o alla carenza di soldi e tempo, ma anche al peso di sostenere una relazione e una comunicazione autentiche, quando incombe un evento considerato tabù (la morte) e mai elaborato assieme, ma consegnato alle competenze fisiopatologiche di questo o quell’istituto, di questo o quello specialista. Se una donna incinta ritiene candidamente di non dover pensare al proprio stato, perché il ginecologo le ha detto che tutto va bene, ella non mette a frutto il prezioso tempo di gestazione e preparazione al parto, un tempo essenziale per scegliere e plasmare il proprio atteggiamento di madre, moglie e donna. Questo è un lavoro etico, non meramente psicobiologico, che comporta il contatto con le proprie memorie, emozioni, credenze e l’interpretazione dei vissuti nuovi che la gravidanza comporta. Non stupisce pertanto che, se questa rimozione infantile viene perpetrata, i sogni delle donne si popolino di simboli e termini tecnici e di protagonisti (soprattutto nel caso della procreazione artificiale) provenienti dall’universo clinico (l’ostetrico rappresentato come una sorta di semidio della fecondità).
L’idolatria di una medicina, che si attribuisca addirittura il compito di provvedere al completo benessere fisico, psichico e sociale, scambia inoltre le cause con gli effetti. Un disoccupato è malato? Il suo indubbio disagio sociale, la sua indignazione, l’inquietudine, con cui esprime le proprie rivendicazioni, sono una malattia? Ed è forse ai medici che il dissidente, più in genere il «diverso» deve essere indirizzato, quando reclama i suoi diritti di cittadinanza e respinge gli infantili tentativi di offrirgli un intrattenimento divertente o una sedazione a buon mercato? Il fraintendimento della nozione di cura ha storicamente prodotto aberrazioni memorabili. Esponenti di minoranze politiche in regimi totalitari venivano considerati patologicamente nevrotici e condannati a riabilitazioni forzate in qualche struttura sanitaria di contenimento. Ci sono voluti anni, proteste e dibattiti prima che l’omosessualità venisse tolta, in quanto tale, dall’elenco americano delle condizioni mentalmente disturbate. Alcune congetture mediche ottocentesche teorizzavano una «naturale» disuguaglianza tra maschi e femmine, finendo per contrastare i movimenti di emancipazione.
La donna - si affermava - ha una costituzione fisica debole, è più umida e fredda nei liquidi umorali, i suoi tessuti sono spugnosi e molli, il connettivo sottocutaneo è pieno di grasso bianco e compatto, occhio e orecchio ricevono meno stimoli sensoriali, la cute è particolarmente reattiva, il corpo è centrato nell’apparato riproduttivo, la fisiologia degli apparati è flessibile e istintiva. Ne derivano tratti psicologici fissi: è capricciosa, incline a raccontare, insegue i particolari, regna sul cuore, non è atta all’indagine causale. Come i bambini, i vecchi, gli eunuchi e gli uomini «privati dello sperma», il femminile è più esposto a malattie nervose. Tutto ciò controindica l’applicazione a studi medici: non è la scienza il posto delle donne.